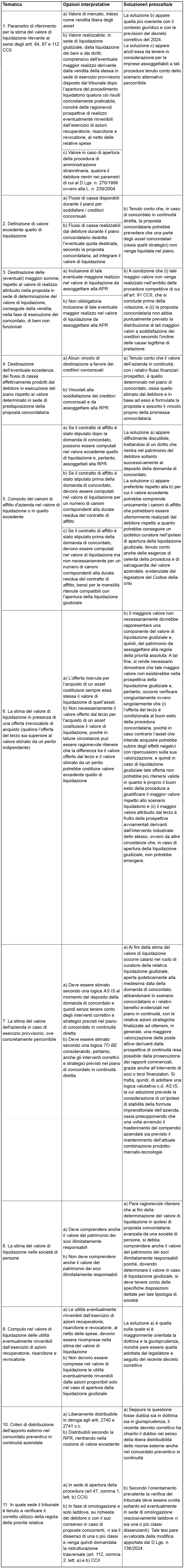Saggio
Il valore di liquidazione nel codice della crisi e dell’insolvenza dal testo originario al D.Lgs. n. 136/2024*
Alessandro Turchi, Dottore commercialista in Milano
18 Agosto 2025
Lo scritto è edito in “NUOVI STUDI SUL DIRITTO DELLA CRISI”, Speciale Dirittodellacrisi.it, a cura di L. De Simone, M. Fabiani e S. Leuzzi, 2025”.
The study represents the further implementation of the contribution published on 20th of September 2024, which is the outcome of the research project entrusted by Diritto della crisi to the Author, focusing on a new and currently controversial topic, such as the distribution of the restructuring value. The topic is addressed by attempting to identify a shared notion of liquidation value, with the aim of allowing the judicial authority to assess the legitimacy and convenience aspects in concrete terms. This paper was updated in April 2025.
It is published in “NUOVI STUDI SUL DIRITTO DELLA CRISI”, Special Issue of Dirittodellacrisi.it, edited by L. De Simone, M. Fabiani, and S. Leuzzi, 2025".


Cambia dimensione testo
Sommario:
2.1 . Il parametro comparativo dell’amministrazione straordinaria
2.2 . La valutazione d’azienda come processo complesso e influenzato da molteplici variabili
3 . La centralità del valore di liquidazione ai fini comparativi
4.1 . Il valore di liquidazione
4.2 . Il valore eccedente quello di liquidazione
6 . La stima del valore di liquidazione in presenza di una offerta irrevocabile di acquisto
7 . Il valore di liquidazione del patrimonio nelle società di persone
8 . I criteri di stima del valore di liquidazione tra dottrina e giurisprudenza
10.1 . La composizione negoziata
11 . Il valore riservato ai soci nel concordato preventivo in continuità aziendale
11.1 . Il ruolo degli equity holders nella Direttiva Insolvency
11.2 . Il valore riservato ai soci nel CCII
13 . Il tentativo di uno sguardo comparato
13.1 . Chapter 11 statunitense – Subchapter II
13.2 . Chapter 11 statunitense – Subchapter V
13.4 . Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in Olanda
13.5 . La Ordinance n. 2021-1193 e il Code de Commerce in Francia
13.6 . La nuova Ley Concorsual in Spagna
13.7 . Il Corporate Insolvency and Governance Act 2020 – Part 26A Companies Act 2006 nel Regno Unito
13.8 . Sintesi dello sguardo al diritto comparato
15.1 . Calzaturificio Skandia S.p.a. – Trib. Treviso R.G. 20/2023 P.U. e R.G. 1/2024 C.P. omologato
15.2 . Sergio Lunatici S.p.a. – Trib. Lucca R.G. 9-2/2022 P.U. e R.G. 1/2023 C.P. omologato
15.3 . Co.ret. s.a.s. – Trib. Lecce R.G. 75/2022 C.P. omologato
15.4 . Respitalia Società Benefit a Socio Unico – Trib. Milano R.G. 327/2023 C.P. omologato
15.6 . Doplà S.p.a. – Trib. Treviso R.G. C.S. 1/2023 Concordato semplificato omologato
15.7 . Repe S.r.l. – Trib. Latina C66/2023 P.U. omologato
15.8 . Cimolai S.p.a. – Trib. Trieste R.G. 5-1/2022 P.U. C.P. omologato
15.9 . Edilcave S.r.l. in liquidazione – Trib. Mantova 45/2023 P.U. omologato
- valore di liquidazione ordinaria: “stima del valore lordo che tipicamente si potrebbe realizzare dalla vendita per liquidazione di un bene, avendo a disposizione un ragionevole periodo di tempo per trovare uno o più acquirenti, nelle condizioni e nel luogo in cui si trova [“as is, where is”]”;
- valore di liquidazione forzata: “stima del valore lordo che tipicamente si potrebbe realizzare dalla vendita di un bene mediante asta pubblica adeguatamente pubblicizzata, il cui venditore è costretto a vendere il bene nell’immediato, nelle condizioni e nel luogo in cui il bene si trova”;
- valore di liquidazione “in place”: “stima del valore lordo che tipicamente si potrebbe realizzare dalla vendita in blocco di un complesso non più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie e non operativo, offerto in forma adeguatamente pubblicizzata, con il venditore costretto a vendere e nel presupposto che la struttura sia venduta in blocco ed intatta”.
Basti anche pensare alle regole previste nell’ambito della liquidazione giudiziale e delineate dall’art. 216 CCII, secondo cui devono essere celebrati almeno tre tentativi di vendita all’anno e ad ogni tentativo che ha avuto insuccesso deve conseguire un ribasso. Pertanto, nell’arco di un anno il bene è destinato a subire un deprezzamento del prezzo di vendita, diversamente da quanto potrebbe accadere nel libero mercato[31].
È stato autorevolmente osservato come il concetto di valore di liquidazione rilevante ai fini della tutela di classe collegata alla regola sulla ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, lett. a) CCII) potrebbe assumere un significato non coincidente con quello riferito al valore ritraibile dalla liquidazione giudiziale (comprensivo del presumibile ricavato delle azioni di massa), che sta alla base della tutela individuale fondata sul c.d. best interest of creditors (art. 112, comma 3, lett. c) CCII) e che deve essere specificatamente indicato nel piano di concordato ex art. 87, comma 1, lt c.) CCII. Tali concetti, secondo tale orientamento, sebbene siano entrambi riconducibili a una prognosi del valore di liquidazione degli assets, sono funzionali a preservare regimi di tutela differenti: da un lato, la tutela di classe dinanzi al mancato rispetto della regola distributiva della APR sul valore di liquidazione (art. 112, comma 2, lett. a), nell’ambito della quale la mancata approvazione di tutte le classi è elevata a condizione ostativa all’omologazione, a prescindere dall’opposizione individuale di un dissenziente; dall’altro, la tutela individuale ancorata alla verifica del best interest of creditors (art. 112, comma 3) che, all’esatto contrario, opera nel solo caso di contestazione della convenienza da parte del dissenziente, ma a prescindere dalla circostanza che il piano sia approvato da tutte o solo da alcune delle classi. Pertanto, se si volesse preservare l’autonomia dei due rimedi, occorrerebbe tenere distinti i significati che, nei due contesti, assume il valore di liquidazione: (i) il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a) CCII costituisce l’oggetto di una regola di giustizia distributiva a cui il contenuto dispositivo del piano concordatario deve conformarsi ex ante se si vuol ambire alla ristrutturazione trasversale dei debiti (in mancanza del consenso di tutte le classi), con la conseguenza che il suo perimetro non può che riferirsi a tutti i valori patrimoniali disponibili per la distribuzione in quanto esistenti e realizzabili alla data e nel contesto del piano stesso, ma non può comprendere valori futuri ricavabili nel solo caso in cui il piano non dovesse perfezionarsi (il ricavato di ipotetiche azioni esperibili nella liquidazione giudiziale), ne´ potrebbe all’opposto, subire decurtazioni in considerazione della presumibile perdita di valore degli elementi dell’attivo in caso di liquidazione concorsuale; (ii) il valore di liquidazione alla base della verifica del best interest of creditors ex art. 112, comma 3, CCII non atterrebbe alla distribuzione di valori esistenti o attesi nel contesto del piano concordatario, ma costituisce un parametro di valutazione ex post della idoneità della proposta a conseguire un risultato utile in termini di efficienza allocativa, proiettandosi sui valori realizzabili nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale con specifica finalità di impedire che il concordato possa vincolare un singolo dissenziente che, in mancanza dell’approvazione del piano concordatario, possa conseguire un miglior soddisfacimento delle proprie ragioni di credito[32].
Il recente decreto correttivo è intervenuto in modo incisivo nell’ambito della nozione di valore di liquidazione, permettendo così, ad avviso di chi scrive, di risolvere il dubbio circa il parametro di riferimento ai fini della sua stima, nonché il dubbio che il valore di liquidazione rilavante ai fini dell’opposizione ex art. 112, comma 3, CCII fosse differente rispetto a quello cui si riferisce l’art. 84, comma 6, CCII in tema di regole distributive. L’intervento del legislatore ha consentito, infatti, di specificare e dettagliare in maniera più approfondita i parametri che concorrono alla determinazione del valore di liquidazione. Come autorevolmente sostenuto, tali parametri possono (e devono) essere utilizzati anche per determinare il valore “realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” ex art. 84, comma 5, CCII. Tale modifica legislativa, perciò, ha contribuito ad offrire alcuni nuovi parametri che il professionista indipendente dovrà tenere in considerazione ai fini di cui all’art. 84, comma 5, CCII e, quindi, per valutare l’eventuale incapienza dei beni o diritti presenti nel patrimonio del debitore sui quali insistano privilegi. Qualora la proposta di concordato preveda la falcidia dei crediti con privilegio generale, la relazione di stima ex art. 84, comma 5, CCII avrà ad oggetto l’intero patrimonio dell’imprenditore, eventualmente comprensivo anche dei beni immobili nell’ipotesi di privilegi generali con collazione sussidiaria, con conseguente applicazione dell’art. 87, comma 1, lett. c) CCII[33].
In particolare, il recente decreto correttivo ha precisato la definizione di valore di liquidazione contenuta all’art. 87, comma 1, lett. c) CCII come segue “valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”[34]. La circostanza per cui il parametro di riferimento ai fini della stima del valore di liquidazione sia sempre rappresentato dalla liquidazione giudiziale, nonché il fatto che oggi vi è una unica nozione di valore di liquidazione[35], alla base tanto del valore minimo da assicurare ai creditori (art. 112, comma 3)[36] quanto della regola di distribuzione della APR e della stima del degrado dei creditori privilegiati (art. 84, comma 5 e 6, CCII)[37], si rinviene dalla lettura delle norme modificate: la nozione di valore di liquidazione sopraccitata di cui all’art. 87 lt c) è richiamata, quasi ossessivamente, in ogni punto in cui compare il concetto di valore di liquidazione nel concordato preventivo[38][39]. In aggiunta, come sopra accennato, se prima del recente decreto correttivo vi erano alcune disposizioni che continuavano a fare riferimento al “valore di mercato”, a seguito dell’intervento correttivo, tale riferimento è rimasto unicamente all’art. 75, lasciando un generico riferimento a “valore” nell’art. 100 CCII. Inoltre, con un intervento che, ad avviso di chi scrive, rafforza in modo decisivo quanto sopra esposto, in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, il legislatore non soltanto ha espunto il riferimento al “valore di mercato”, ma ha anche precisato che la soddisfazione minima da assicurare ai creditori pubblici è rappresentata dal “ricavato in caso di liquidazione giudiziale”[40]. La Relazione Illustrativa al recente decreto correttivo è molto chiara sul punto: la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico sia quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” con conseguente eliminazione del riferimento al valore “di mercato”, si colloca in linea con ogni altra disposizione del CCII che prevede il confronto tra la soddisfazione proposta dal debitore nell’ambito della procedura concordataria e la soddisfazione ricavabile in caso di liquidazione, rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione[41].
In conclusione, da quanto sopra emerge altresì che il piano concordatario imperniato sulla continuità indiretta dovrebbe dimostrare di generare un valore “eccedente” quello di liquidazione, ossia si tratta di dimostrare come la vendita dell’azienda sul mercato, da parte della procedura concordataria, riesca ad assicurare maggiori incassi rispetto a quanto avverrebbe ad opera di un ipotetico curatore, ove fosse prevedibile la continuazione dell’impresa ai sensi dell’art. 211 CCII[104]. Dunque, come osservato da autorevole dottrina, potrebbe sembrare che gli spazi potenziali della relative priority rule applicabile anche alla continuità indiretta siano in pratica molto limitati. In realtà è proprio l’esperienza empirica che evidenzia svariati esempi di aziende oggetto di concordati ove si pianifichi la loro utile ricollocazione e che, ove invece liquidate secondo il modello della liquidazione giudiziale, potrebbero conseguire obiettivi riallocativi molto più limitati e meno convenienti, a causa, ad esempio, della prospettiva ragionevole di perdere talune relazioni convenzionali determinanti ai fini del realizzo integrale del loro “valore” (si pensi, a titolo esemplificativo, agli appalti pubblici); come pure vi sono casi in cui la prosecuzione dell’attività nella liquidazione giudiziale sarebbe comunque più disagevole rispetto al concordato, e quindi l’arresto dell’impresa porterebbe inevitabilmente alla depressione dei componenti di valore, soprattutto di ordine immateriale[105].
In modo, ad avviso di chi scrive, non dissimile si è espresso il Tribunale di Spoleto con provvedimento del 4 luglio 2024[111], ove si evince che concorre a formare il valore di liquidazione l’importo corrispondente all’offerta di acquisto irrevocabile ricevuta dal terzo, salvo che l’offerente abbia meglio precisato i termini dell’offerta tra il valore di stima (che costituisce quindi un elemento del valore di liquidazione) e il surplus apportato al concordato, che verrà versato in caso di omologazione del concordato e quindi non esisterebbe nella liquidazione giudiziale[112]. Anche secondo tale impostazione, pertanto, pare che, se l’offerente indica una somma a titolo di prezzo e un’altra a titolo di ulteriore apporto, solo la prima coincide con il valore di liquidazione.
Un ulteriore pronuncia giudiziale del Tribunale di Bergamo del 30 novembre 2023[113], sebbene riferita al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, rileva in questa sede in quanto fornisce utili spunti di approfondimento in merito al percorso di stima del valore di liquidazione con specifico riferimento al valore di beni rispetto ai quali il debitore ha già ricevuto delle proposte irrevocabili di acquisto che, nel caso di specie, non sono condizionate all’omologa dello strumento di regolazione prescelto. In particolare, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la comparazione della proposta del debitore con la liquidazione giudiziale non possa esaurirsi nel mero confronto tra la vendita sottostante alla proposta di accordo in esame e l’esito della procedura di vendita in sede di liquidazione giudiziale. Infatti, occorre considerare che “tali offerte sarebbero verosimilmente coltivabili anche in sede di liquidazione giudiziale e ciò non solo perché, presumendosi fondate su scelta razionale di operatore economico interessato al lucro della propria impresa, esse dovrebbero risultare insensibili alla cornice procedimentale e concorsuale (ADR o L.G.) in cui s’inscriva la vendita, ma anche perché le offerte in questione non sono condizionate all’omologa ma puramente e semplicemente vincolate ad un termine”. Dunque, conclude il tribunale, “non si può assumere, sulla base di una riserva mentale o tacita presupposizione, che le offerte valgano solo in questa sede e non in quella liquidatoria. La scelta dello strumento concorsuale al fine di raccogliere le offerte di contestata imperdibilità è dunque irrilevante”[114].
Altro precedente di merito che, seppure riferito al procedimento di omologa di un concordato semplificato, offre utili spunti per rispondere al quesito oggetto del presente paragrafo è costituito dal Trib. di Treviso del 3 ottobre 2023[115]. Nel caso di specie, in sede di giudizio di omologazione un creditore eccepisce che, non essendo l’offerta del terzo per l’acquisto di uno dei rami aziendali (comprensivo dei beni mobili e delle rimanenze ad esso afferenti) subordinata all’omologa ma solo alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, la comparazione tra i due scenari (liquidazione giudiziale e concordato preventivo) doveva tener conto dello stesso valore di realizzazione per tale ramo e non, invece, il minor valore di perizia assunto come riferimento nella stima dello scenario di liquidazione giudiziale da parte della ricorrente. Il Tribunale ha statuito che “Il motivo non può trovare accoglimento perché la stima del valore dell’azienda nello scenario liquidatorio, pur considerando la vendita unitaria e non atomistica in coerenza con quanto dispone l’art. 214 comma 1 CCI, deve avvenire con riferimento alla data di apertura del concorso. La vendita del Ramo è avvenuta nel contesto della soluzione concordataria ed è il risultato della negoziazione tra le parti condotta successivamente alla composizione negoziata e in funzione della domanda di concordato. Non vi è alcuna evidenza che … [il terzo] avrebbe acquistato l’azienda e alle medesime condizioni anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale”.
Uno spunto di riflessione fornito dalla giurisprudenza che pare confermare la tesi sopra sostenuta è fornito dal Tribunale di Lecce del 9 febbraio 2024, ove si legge che “nel caso di liquidazione giudiziale, la cessione [del ramo d’azienda attualmente condotto in affitto] … potrebbe avvenire anche a prezzo inferiore [rispetto alla stima fornita dal perito nominato dal tribunale e pari all’offerta irrevocabile di acquisto formulata dal terzo che attualmente conduce in affitto il ramo aziendale], posto che l’impegno irrevocabile all’acquisto da parte dell’affittuaria ha valenza limitata alla presente procedura”. Infatti, precisa il Tribunale che “con la proposta concordataria stante la proposta irrevocabile di acquisto della … tale prezzo sarà acquisito al patrimonio concordatario; nella ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, non vi è alcun elemento che consenta di affermare con certezza che si riesca a pervenire quantomeno allo stesso risultato e non, invece, ad una cessione a prezzo via via ridotto”[116].
Un ulteriore provvedimento di merito che tratta del tema in questione si rinviene in Trib. di Reggio Emilia del 18 marzo 2025[117], ove viene affermata la facoltà del debitore di distribuire secondo la regola della priorità relativa il maggior prezzo derivante dalla cessione dell’azienda durante la procedura di concordato, in quanto definibile quale “valore eccedente quello di liquidazione”. Invero, nel provvedimento in esame si evince che “il delta tra valore di liquidazione, inteso sotto questo profilo come il prezzo ricavabile nell’ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell’azienda in esercizio, e il maggior prezzo in concreto ricavato dalla cessione dell’azienda durante la procedura concordataria, ben possa qualificarsi in termini di «valore eccedente quello di liquidazione»”[118].
Infine, preme evidenziare che, come meglio esposto al par. 9, in presenza di una offerta irrevocabile di acquisto e contestuale impegno, da parte del medesimo soggetto che ha formulato l’offerta medesima, di apporto di finanza esterna, quest’ultima potrà essere distribuita liberamente a condizione che non sia “collegata in senso giuridico ed economico anche come tempistiche e valorizzazione rispetto all’affitto di azienda ed all’impegno alla cessione … previsto a fine piano, non apparendo come corrispettivo dell’acquisto aziendale”[119].
In conclusione, è ragionevole ritenere che nel caso in cui un terzo dovesse formulare una offerta di acquisto dell’azienda (o di un ramo di essa o di un altro componente del patrimonio del debitore) ad un valore maggiore rispetto alla stima del valore di liquidazione, tale maggiore valore non necessariamente dovrebbe rappresentare una componente del valore di liquidazione giudiziale e, quindi, del patrimonio da assoggettare alla regola della priorità assoluta[120]. A tal fine, si rende necessario dimostrare che tale maggior valore non esisterebbe nella prospettiva della liquidazione giudiziale e, pertanto, occorre verificare congiuntamente ovvero singolarmente che (i) l’offerta del terzo è condizionata al buon esito della procedura concordataria, poiché in caso contrario l’asset che intende acquisire potrebbe subire degli effetti negativi con ripercussioni sulla sua valorizzazione, e quindi in caso di liquidazione giudiziale tale offerta non potrebbe più ritenersi valida in quanto è proprio il buon esito della procedura a giustificare il maggior valore rispetto allo scenario liquidatorio e (ii) il maggior valore attribuito dal terzo è frutto delle prospettive avviamentali derivanti dall’intervento industriale dello stesso ovvero da altre circostanze che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, non potrebbe emergere.
In aggiunta, poiché anche il fattore temporale con il quale i creditori vengono soddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale riveste un rilievo non solo fattuale, ma anche giuridico nella valutazione della soddisfazione dei creditori, al valore di liquidazione andrebbe applicato un tasso di sconto che tenga conto del presumibile tempo di realizzo dell’attivo (particolarmente lungo nel caso di esiti positivi sperati da azioni recuperatorie e risarcitorie) che consenta di attualizzare lo stesso, rendendolo comparabile con la tempistica indicata nel piano di concordato per la soddisfazione dei creditori[135].
Tale attualizzazione, tuttavia, ad avviso di chi scrive, non solo deve essere intesa in termini di tempo, ma anche di rischiosità connessa alla situazione di crisi (o insolvenza) in cui versa il debitore. Da ciò discende che, ai fini della stima del valore di liquidazione di un’azienda (o ramo di essa), si rende necessaria l’applicazione di un congruo haircut, che tenga in debita considerazione lo stato di crisi (o anche, di insolvenza) del debitore[136]. Invero, valutare un’azienda in stadio di crisi o di insolvenza presenta indubbie criticità dovute al contesto di incertezza operativa che la medesima si trova ad affrontare. Sul tema, come autorevolmente osservato in dottrina, i principali elementi che distinguono le imprese in difficoltà rispetto alle imprese in condizioni ordinarie sono i seguenti[137]:
a) il profilo di maggiore rischio: riconducibile a rischi connessi all’impossibilità di proiettare nel futuro uno svolgimento del business in continuità senza interventi correttivi (di ristrutturazione operativa o finanziaria), i rischi connessi alle discontinuità che gli interventi correttivi comportano e quindi di deragliamento dell’azione correttiva pianificata, i rischi di dover riconoscere sconti rilevanti in sede di liquidazione di attività o di emissione di nuovi strumenti di equity o di debito;
b) la natura e l’origine dello stato di difficoltà: con riferimento alla natura della difficoltà, si può distinguere tra (i) cause idiosincratiche, riferibili a circostanze ed eventi propri della specifica impresa quali ad esempio errori gestionali, frodi, scadenza di brevetti, calamità naturali, perdita di persone chiave, e (ii) cause strutturali comuni a tutte le imprese del settore o talune categorie di imprese che operano nel medesimo settore quali ad esempio flessioni della domanda, discontinuità tecnologiche. In relazione all’origine della crisi, si può distinguere tra (i) cause operative, riferibili a condizioni economiche sfavorevoli, settore in crisi per mancanza di domanda o per lievitazione dei costi non traslabile sui prezzi, debolezze competitive dell’impresa, modello di business superato, errori compiuti nel passato a seguito di previsioni eccessivamente ottimistiche con conseguenti errori strategici e manageriali, e (ii) cause finanziarie, riconducibili a illiquidità, indebitamento eccessivo e costi finanziari sproporzionati;
c) le tipologie di rischi tipici, che si possono esprimere in termini di rischio di aggressione del patrimonio da parte dei creditori, rischi operativi che assumono la forma di costi indiretti di dissesto, rischi operativi legati alla gestione che ha portato alla crisi, rischi gestionali, legati alla indisponibilità di adeguati supporti informativi o di adeguate competenze manageriali, rischi connessi ai tempi ridotti di azione, rischi connessi alla volatilità delle condizioni di contesto, rischi di diluizione del capitale, rischi di discontinuità gestionale e rischio di piani goal oriented.
Le considerazioni svolte al par. 6 si ritiene possano essere condivise anche ai fini della stima del valore di liquidazione dell’azienda in esercizio nell’ambito della liquidazione giudiziale. Infatti, come evidenziato in tale paragrafo, a parere dello scrivente il valore eccedente (sul quale si può applicare la regola della priorità relativa) è costituito unicamente dall’eventuale maggior valore ritraibile dalla vendita dell’azienda in esercizio rispetto a quello ritraibile dalla vendita in sede di liquidazione giudiziale ed eventuale esercizio provvisorio. Ciò significa che, ai fini della determinazione del valore di liquidazione, sebbene vada stimato, ove possibile, in ottica dinamica, occorre tenere conto dell’eventuale plusvalore della continuità (minima) che sarebbe conseguibile dalla vendita dell’azienda in esercizio, ossia dopo un eventuale esercizio provvisorio, e non anche il plusvalore derivante dalla continuità come prevista nel piano. In questo senso, pertanto, ai fini della stima del valore di liquidazione si rende necessario valutare la percorribilità di una minima continuità aziendale nell’ambito dell’esercizio provvisorio funzionale alla preservazione del valore avviamentale nella prospettiva della successiva alienazione dell’azienda a terzi, mentre non devono essere considerati i benefici evidenziati nel piano di concordato per effetto delle relative azioni strategiche finalizzate ad ottenere una maggiore valorizzazione delle poste attive derivanti dalla prospettiva di continuità resa possibile dalla prosecuzione dei rapporti commerciali, grazie anche (eventualmente) all’intervento di soci o terzi finanziatori[138]. D’altronde, la continuità consente, almeno in via teorica, di evitare quello “sconto” insito in ogni liquidazione forzosa, ovvero in ogni conversione coattiva di beni in denaro; il valore aggiunto di una ristrutturazione (da cui trae origine il surplus) è proprio rappresentato dalla possibilità di evitare lo sconto insito nella natura stessa di una cessione forzosa, nonché nella possibilità di sfruttare talune azioni strategiche evidentemente non realizzabili nello scenario liquidatorio. In termini pratici, ai fini della determinazione del valore di liquidazione occorre calarsi nel ruolo di curatore della relativa liquidazione giudiziale, aperta ipoteticamente alla medesima data di presentazione del concordato[139], abbandonare lo scenario concordatario e i relativi benefici evidenziati nel piano in continuità, con le relative azioni strategiche finalizzate ad ottenere un incremento dei ricavi o una riduzione dei costi e, più in generale, una maggiore valorizzazione delle poste attive derivanti dalla prospettiva di continuità resa possibile dalla prosecuzione dei rapporti commerciali, grazie anche all’intervento di soci o terzi finanziatori. Si tratta, quindi, di adottare una logica valutativa cd. as is (che si contrappone alla cd. valutazione dello scenario to be), la cui adozione prevede la considerazione di un’ipotesi di stabilità della formula imprenditoriale dell’azienda, ossia presupponendo che una volta avvenuto il trasferimento del compendio aziendale sia previsto il mantenimento dell’attuale combinazione prodotto-mercato-tecnologie. Pertanto, la determinazione del valore di liquidazione deve fondarsi su una prospettiva dinamica, che privilegi – laddove percorribile – l’ipotesi di vendita unitaria dell’azienda nello stato di fatto in cui si trova e, pertanto, in assenza di interventi di ristrutturazione[140]. Inoltre, le valutazioni dovrebbero essere uniformate non già ai principi di redazione del bilancio di cui all’art. 2423 bis c.c., che prevedono che siano effettuate nell’ottica della continuazione dell’attività (c.d. going concern), ma a criteri di liquidazione. Ciò in quanto la procedura di liquidazione giudiziale è finalizzata a liquidare l’attivo (seppure con la preferenza a salvaguardare l’organismo produttivo) e, pertanto, l’impresa (in esercizio provvisorio) non potrebbe comunque essere considerata alla stregua di un’entità in funzionamento in grado di operare per un prevedibile arco temporale futuro[141].
In ordine ai criteri di stima del valore di liquidazione, ad avviso di chi scrive, la valutazione della percorribilità dell’esercizio provvisorio non può prescindere da un attento esame della redditività aziendale; ciò in quanto, in caso di redditività negativa, difficilmente una ipotetica curatela avrebbe interesse a proseguire l’attività d’impresa, sebbene funzionale al successivo trasferimento a terzi, in quanto ciò comporterebbe ragionevolmente un aggravio delle passività che, in ossequio all’art. 6 CCII, sono assistite dal rango prededucibile. Sul tema, lo scenario della liquidazione giudiziale potrebbe differenziarsi rispetto a quella della apertura della procedura di amministrazione straordinaria. In ipotesi di badwill, infatti, nelle procedure fallimentari difficilmente viene esercitato l’esercizio provvisorio[142]. Invero, come noto, il legislatore nell’ambito dell’amministrazione straordinaria pare ammettere la prosecuzione dell’attività anche in caso di redditività negativa, stante anche le diverse finalità sottese alla procedura amministrativa[143]. Infatti, come autorevolmente evidenziato[144], per rendere percorribile un esercizio provvisorio è necessario che gli assetti gestionali e strategici restino invariati rispetto alla gestione precedente (ossia quella che ha gestito l’azienda prima dell’apertura della liquidazione giudiziale) poiché il curatore ragionevolmente non è nelle condizioni di apportare interventi correttivi tipici di un percorso di turnaround che consenta all’impresa di uscire risanata. Pertanto, poiché il curatore eredita l’azienda con le caratteristiche economiche e finanziarie di quel momento, ciò che assume rilievo sono i risultati storici che quel complesso ha cumulato nei vari esercizi (certamente depurati da elementi non caratteristici o riconducibili ad atti di mala gestio). Inoltre, le dinamiche di deterioramento della redditività (rinvenibile dall’andamento dell’EBITDA), ossia la capacità di bruciare cassa di quel complesso, non si interrompono con l’apertura della liquidazione giudiziale; al contrario, ragionevolmente tale redditività assumerà connotati ancora maggiormente negativi a seguito dell’apertura della procedura liquidatoria[145]. In questo contesto, quindi, la previsione di un esercizio provvisorio non appare coerente, tenuto conto che le perdite crescenti di redditività potrebbero avere l’effetto di assorbire il maggior valore attribuibile ai beni unitariamente considerati, riducendo il differenziale di valore tra lo scenario di prosecuzione temporanea dell’attività e di cessione atomistica dei beni, rafforzando così la convenienza della seconda ipotesi rispetto alla prima.
A favore della conclusione per cui nella determinazione del valore di liquidazione si debba tenere conto della possibilità di disporre l’esercizio provvisorio, milita anche la considerazione per cui il debitore, approcciandosi ad un concordato in continuità aziendale, si presume che abbia ancora a disposizione un’azienda o un ramo di essa in grado di funzionare e produrre valore; pertanto, se si ritiene che sussista una qualche utilità alla prosecuzione dell’attività nell’ambito concordatario, sarebbe illogico non valorizzare il complesso aziendale in esercizio. D’altronde, l’esercizio provvisorio è istituto poco utilizzato anche per la difficoltà del tribunale e del curatore di valutare, con l’indispensabile rapidità, se vi siano i presupposti per darvi corso. Tuttavia, se alla liquidazione giudiziale si giunge in esito ad una proposta di concordato in continuità che non abbia avuto esito positivo, tali difficoltà dovrebbero essere decisamente attenuate. Da qui la conclusione per cui nella determinazione del valore di liquidazione si deve tenere conto della possibilità di disporre l’esercizio provvisorio, quantomeno in via potenziale, potendo essere escluso soltanto se, con motivato e convincente assunto, si dimostri che tale istituto non possa essere proficuamente attuato nel caso specifico[146]. E questo, a maggior ragione, qualora siano state formulate offerte di acquisto dell’azienda funzionante.
Altro elemento che, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere dirimente ai fini della valutazione della percorribilità dell’esercizio provvisorio e quindi della sua preferibilità rispetto ad una liquidazione atomistica dei beni e diritti è rappresentato dal settore di riferimento e, conseguentemente, dall’appetibilità dell’azienda in esercizio per un potenziale acquirente. Infatti, nell’ipotesi in cui l’azienda operi in un settore in crisi[147], che in quanto tale si connota per una scarsa (se non addirittura assente) redditività e attrattività, l’avvio di un esercizio provvisorio si connota per una maggiore rischiosità di insuccesso, stante (i) la difficoltà per una ipotetica curatela di conseguire risultati economici positivi con conseguente rischio di aggravio delle spese prededucibili e (ii) la difficoltà di individuare, in tempi celeri, un compratore interessato all’azienda in esercizio.
Sul tema, pare che l’orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente sia nel senso di ritenere che il valore di liquidazione debba assumere connotati dinamici, ossia vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell’azienda o di singoli rami, ovvero vadano spiegate in maniera analitica e completa le ragioni dell’impossibilità di cedere l’azienda nel suo complesso o per singoli rami[148].
Ritenuto che ai fini della stima del valore di liquidazione occorre verificare se, al momento della domanda di concordato, l’azienda sia o meno nelle condizioni di essere posta in esercizio provvisorio, si pone la questione se ricomprendere in tale valore anche l’utile (prospetticamente) percepibile durante l’esercizio provvisorio, inteso come differenza tra ricavi e costi sostenuti dalla curatela nell’esercizio dell’impresa in liquidazione giudiziale. Ad avviso di chi scrive e premessa la necessità di valutare la concreta praticabilità dell’esercizio d’impresa in liquidazione giudiziale, tenuto conto che, ai sensi dell’art 87, comma 1, lett. c) CCII la data di riferimento ai fini della stima del valore di liquidazione è rappresentata dalla “domanda di concordato”, tale differenza di componenti reddituali realizzata nell’ambito dell’esercizio dell’impresa da parte della curatela non dovrebbe essere ricompreso nella stima del valore di liquidazione in quanto ciò che eventualmente avanza nell’ambito dell’esercizio provvisorio non rientra nel patrimonio del debitore alla data della domanda di concordato. In tal caso, dunque, rappresenta valore di liquidazione l’azienda (in esercizio) e non il valore dei beni atomisticamente considerati.
Secondo autorevole dottrina, il rispetto delle regole distributive non rientra nel controllo di ritualità che il tribunale deve compiere in sede di apertura della procedura di concordato, bensì soltanto ed eventualmente in sede di omologazione[221]. In tale sede, il tribunale può operare un controllo sul rispetto delle regole distributive (sia quelle c.d. verticali sia quelle c.d. orizzontali) solo ed esclusivamente laddove vi sia una o più classi dissenzienti (art. 112, comma 2, lett. b), CCII). Pertanto, qualora la proposta sia stata approvata da tutte le classi votanti, il tribunale non può compiere in sede di omologazione il controllo sul rispetto delle regole distributive. Sarebbe, infatti, contraddittorio attribuire al tribunale il potere/dovere di compiere la verifica sull’osservanza delle regole distributive in sede di apertura, quando la votazione non si è ancora tenuta e non è noto se la proposta sarà approvata dall’unanimità delle classi o meno, poiché questo significherebbe che l’autorità giudiziaria dovrebbe sempre compiere in sede di apertura della procedura una verifica che, invece, in sede di omologazione sarebbe solo eventuale e richiesta unicamente nel caso di dissenso di una o più classi[222]. Invero, seguendo le chiare indicazioni pervenute dalla Direttiva (UE) 1023/2019[223], è soltanto in presenza di opposizioni fondate sull’esistenza di un pregiudizio arrecato al creditore dissenziente rispetto alla liquidazione giudiziale che il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale, la quale rappresenta una operazione imprescindibile ai fini della verifica del rispetto delle condizioni poste dall’art. 112, comma 2, lett. a) e b) CCII nell’ambito della ristrutturazione trasversale[224]. La proposta concordataria, dunque, fermo restando che debba attribuire ai creditori privilegiati almeno il valore di liquidazione della pretesa (art. 84, comma 5, CCII)[225], può essere confezionata anche in deroga al criterio distributivo del surplus concordatario; sarà poi la classe, con il proprio voto, a decidere se disporre del relativo diritto: in caso di dissenso, il tribunale non sarà tenuto a verificare che nei suoi confronti sia rispettato il criterio di ripartizione del surplus, mentre se la classe vota negativamente alla proposta scatterà, nei suoi confronti, la verifica del rispetto di tale criterio[226].
In conclusione, nel concordato preventivo in continuità la verifica del rispetto del criterio di ripartizione del surplus dovrebbe avvenire solo in fase di omologazione e solo nell’ipotesi di classe dissenziente[234]. La soluzione prospettata, infatti, appare in linea con le indicazioni provenienti dalla Direttiva Insolvency, nonché con quanto rinvenibile dallo sguardo al diritto comparato di cui al paragrafo che segue.
In Olanda nell’ambito del WHOA, il legislatore ha previsto il dovere di rispettare l’ordine delle priorità, in ossequio alla APR, che trova applicazione nel momento in cui uno o più creditori manifestino il proprio dissenso alla approvazione del piano; in tale scenario, e quindi soltanto in caso di dissenso, il tribunale è tenuto a verificare il rispetto dell’ordine delle priorità con specifico riferimento alle classi di creditori dissenzienti. Qualora, invece, il piano non venga approvato da tutte le classi (art. 384, comma 4, lett. b), anche il legislatore olandese ha introdotto un meccanismo di cross class cram down, ove il tribunale non può procedere con la omologazione del piano di ristrutturazione se il valore creato attraverso di esso è distribuito in violazione dell’ordine gerarchico delle priorità, ossia della APR. Tuttavia, il legislatore, sebbene lasci aperte talune perplessità, ammette delle “deviations” rispetto alla APR, ossia qualora vi siano ragionevoli motivi che giustifichino una deviazione da tale ordine e a condizione che i creditori (o i soci) interessati non siano pregiudicati in conseguenza di tale scelta.
In Francia nell’ambito del sauvegarde (e il subprocedimento sauvegarde accélérée) e redressement judiciaire, qualora il piano venga approvato da ciascuna classe, interviene il controllo del tribunale, che, per quanto rileva in questa sede, deve verificare, tra gli altri, che qualora taluni creditori interessati abbiano votato negativamente, nessuno di questi a seguito dell’adozione del piano di ristrutturazione si trovi in una situazione meno favorevole rispetto al soddisfacimento che sarebbe loro prospettato qualora venisse applicato l’ordine delle priorità sugli asset del debitore nell’ambito di una liquidation judiciaire, ovvero in una migliore situazione alternativa qualora il piano di ristrutturazione non venisse omologato dal tribunale. Nell’ipotesi in cui tutte le classi abbiano votato favorevolmente al piano, il debitore può allocare liberamente “the surplus of the plan among the various classes”; pertanto, il piano potrebbe anche prevedere, in tali circostanze, trattamenti differenti nei confronti di classi aventi stesso rango: una delle condizioni attiene specificatamente al rispetto della regola della priorità assoluta anche nell’ordinamento francese. Pur prevedendo il rispetto della APR come regola principale dell’ordinamento il legislatore francese ammette alcune deroghe a tale regola, su richiesta del debitore o del administrateur judiciaire, con il consenso del debitore, purché esse siano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del piano di ristrutturazione e che lo stesso non pregiudichi indebitamente gli interessi o i diritti delle parti interessate.
In Spagna il problema distributivo è stato affrontato in modo difforme a seconda che si tratti o meno di PMI: qualora non si tratti di PMI, si applica la APR, mentre in caso di PMI trova applicazione la RPR. Ancora, una forma di RPR è altresì contemplata per le microimprese in relazione al Procedimiento especial para mocroempresas di cui al Libro III della Ley Concorsual. In caso di non consensual plan, anche il legislatore spagnolo ha introdotto un meccanismo di cross class cram down, che, tra gli altri, richiede la verifica del rispetto della regola della priorità assoluta nei confronti della classe dissenziente. Il legislatore spagnolo, tuttavia, ammette delle deroghe alla APR, consentendo quindi l’applicazione della più flessibile RPR, qualora si renda necessaria al fine di perseguire la sostenibilità dell’impresa, senza pregiudicare ingiustamente i diritti dei creditori che hanno votato negativamente al piano di ristrutturazione. Il dovere di rispettare la APR è posto a carico delle società diverse dalla PMI: per queste ultime, tenuto conto della necessità di contenimento dei costi e di minore complessità, il legislatore esclude il dovere di rispettare l’ordine delle priorità e ammette l’utilizzo della RPR.
Infine, nel Regno Unito con l’approvazione del Corporate Insolvency and Governance Act, il legislatore inglese ha preso posizione in ordine all’applicazione della regola della priorità assoluta, nonché ha introdotto il meccanismo del cross class cram down. Il legislatore inglese lascia ampi margini di discrezionalità alla court: la Explanatory Note al CIGA evidenzia come, a seguito della verifica del rispetto di tali condizioni, la court può comunque decidere di non attivare il meccanismo del cross class cram down laddove ritiene “just and equitable to do so”. Ne discende che nell’ambito della procedura di cui alla Part 26A non trovi applicazione la regola della priorità assoluta, tuttavia, la stessa potrebbe trovare comunque applicazione in ragione dell’ampio potere discrezionale lasciato alla court. Pertanto, nell’ambito della legislazione inglese la regola della priorità assoluta non rappresenta un cardine del nuovo piano di ristrutturazione di cui al Part 26A, poiché viene lasciato ampio margine discrezionale al giudice di decidere quale sia la regola distributiva “just and equitable” nelle singole fattispecie esaminate.
a) Sintesi della società, delle cause della crisi e tipologia di concordato
- produce al 90% per conto terzi e, pertanto, in caso di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, i committenti sicuramente non garantirebbero la continuità del rapporto commerciale tenuto conto che l’attività dovrebbe essere sospesa per la redazione dell’inventario che richiederebbe almeno due mesi, poiché i cui beni sono dislocati in tre nazioni nelle quali opera Calzaturificio;
- i dipendenti delle controllate, come dimostrato dalle recenti dimissioni riscontrate, non sarebbero disponibili a continuare a lavorare in caso di ritardo nei pagamenti delle proprie spettanze e, pertanto, venendo a meno la forza lavoro sarebbe complesso garantire la prosecuzione dell’attività aziendale;
- a far data dal deposito della domanda con riserva, vi sono state ben sei dimissioni di impiegati, per cui è ragionevole ritenere che, in caso di liquidazione giudiziale, il curatore non disporrebbe della forza lavoro necessaria per la prosecuzione dell’attività attraverso l’esercizio provvisorio;
- le forniture di materie prime dalla Cina devono essere pagate all’ordine e tali tempistiche di pagamento sarebbero ragionevolmente difficili da rispettare per una ipotetica curatela;
- opera attraverso il metodo di fornitura just in time, il cui presupposto è quello di consentire ai clienti di non disporre di un proprio magazzino ma di programmare forniture scaglionate da ricevere dopo pochi giorni dalla richiesta; pertanto, in caso di sospensione anche temporanea dell’attività, i clienti resterebbero privi di merce con danni che difficilmente consentirebbero di recuperare il rapporto con il cliente.
- le previsioni di piano al termine dell’esercizio 2023 evidenziano una perdita di euro 343.000 (escludendo la sopravvenienza da stralcio conseguente alla omologazione del concordato preventivo), che sarebbe incompatibile con un eventuale esercizio provvisorio, poiché comporterebbe inevitabilmente un aggravio delle spese in prededuzione;
- l’eventuale esercizio dell’attività da parte del curatore potrebbe consentire al massimo il soddisfacimento degli ordini in corso, ma difficilmente il curatore potrebbe acquisire con un anno di anticipo gli ordini per l’anno successivo rendendo pertanto non appetibile l’acquisizione dall’azienda da parte di un terzo.
Sul tema della non percorribilità dell’esercizio provvisorio si è altresì espresso l’attestatore, nonché anche professionista incaricato a redigere anche la relazione ex art. 84, comma 5, CCII. Quest’ultimo ha ritenuto condivisibili le motivazioni addotte dalla ricorrente per ritenere non praticabile e, quindi, non conveniente per il ceto creditorio, la cessione dell’azienda in esercizio (provvisorio) rispetto alla valutazione atomistica dei singoli beni. Anche il commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 105 CCII ha dato atto di condividere le ragioni esposte dalla Calzaturificio in merito alla opportunità di una stima atomistica dei beni aziendali al fine di una valutazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, come previsto dall’art. 87, c. 1, lett. c, CCII.
c) La stima del valore di liquidazione nella relazione ex art. 84, comma 5, CCII
In primo luogo, si precisa che lo scenario di riferimento adottato dal perito redattore della relazione ex art. 84, comma 5, CCII (in seguito “Perito art. 84”) è stato quello della liquidazione giudiziale[307]. Di seguito si ripercorrono le principali voci dell’attivo valorizzate dal perito ai fini della redazione della perizia di degrado e che assumono rilievo in questa sede in quanto forniscono utili spunti di approfondimento rispetto alle tematiche esposte nelle pagine precedenti.
In primo luogo, con riferimento alla valorizzazione delle immobilizzazioni materiali, costituite da impianti, macchinari e attrezzature industriali, Calzaturificio ha fornito incarico ad un perito. Quest’ultimo ha formulato una valutazione tenuto conto: (i) del costo di acquisto di macchinari o attrezzature nuovi comparabili per caratteristiche intrinseche e di utilità nonché i costi di carico, trasporto, installazione, allacciamento ed adeguamento alle esigenze produttive, (ii) del deprezzamento legato alle condizioni di conservazione ed alla obsolescenza funzionale dei beni, (iii) dei costi di smontaggio, carico e trasporto dei materiali verso altra sede, considerando, nel valore di stima, l’appetibilità dei beni per una ristretta fascia di possibili acquirenti, (iv) la presenza o meno dell’attestazione di conformità europea (CE) al fine di verificare la rispondenza dei beni ai requisiti previsti per la loro utilizzabilità. Il perito ha ritenuto opportuno calcolare, oltre che un coefficiente di obsolescenza funzionale, un ulteriore abbattimento prudenziale variabile fra il 20% ed il 50% per considerare i fattori indicati in precedenza. Tale abbattimento è stato considerato dal Perito art. 84 conforme alle finalità della presente stima e, dunque, alla determinazione del valore di mercato dei beni in caso di liquidazione giudiziale.
Ai fini della valorizzazione delle partecipazioni detenute da Calzaturificio è stato nominato un perito, il quale ha rilasciato la propria relazione peritale. Come si evince nella relazione di degrado, poiché la valutazione delle tre partecipate è stata effettuata in ottica liquidatoria per Calzaturificio e, poiché le partecipate svolgono attività economica esclusivamente nei confronti della capogruppo, il perito ha ritenuto che in caso di cessazione dell’attività da parte di Calzaturificio, anche le controllate cessino di operare. La cessazione dell’attività del debitore, infatti, comporterebbe il venir meno della configurazione di azienda (inteso quale complesso economico funzionante) da parte delle controllate. Di fatto, quindi, i singoli elementi patrimoniali cesserebbero di avere un valore di funzionamento ma dovrebbero essere valutati singolarmente in ottica liquidatoria. In tale contesto, quindi, l’unico metodo concretamente ritenuto applicabile, poste le peculiarità della valutazione in questione, è stato il metodo patrimoniale semplice. È stato escluso, infatti, il metodo patrimoniale complesso, cioè con valutazione separata degli intangibili, siccome le controllate non paiono disporre di immateriali di valore rilevante. Di conseguenza il perito ha ritenuto di valutare le tre partecipate con il metodo patrimoniale semplice. A tal fine, peraltro, ha basato le proprie valutazioni sulle stime del valore dei beni materiali di proprietà delle tre società partecipate sulla base di apposita perizia. Nell’applicare il metodo patrimoniale ha adeguato il valore delle immobilizzazioni materiali delle partecipate al valore indicato da tale perizia e ha rettificato i crediti che le controllate vantano nei confronti del debitore, in considerazione della crisi d’impresa di Calzaturificio che non darà soddisfazione a tali crediti[308] ovvero altri crediti di cui non si prevede la recuperabilità in futuro. Da ultimo, in considerazione dell’ottica liquidatoria è stata applicata un’ulteriore defalcazione del valore ottenuto pari al 10%[309]. Il Perito art. 84 ha ritenuto condivisibili le conclusioni del perito delle partecipazioni in merito agli effetti in termini di cessazione dell’attività delle controllate in caso di liquidazione giudiziale di Calzaturificio, escludendo quindi l’impiego di metodi valutativi basati sui flussi di reddito o di cassa in quanto, di fatto, impossibili da realizzare in futuro, in caso di cessazione dell’attività da parte della società capogruppo, così come i metodi misti (patrimoniale-reddituale) per le medesime considerazioni. Anche l’impiego dei metodi multipli è stato escluso in quanto trattasi di metodologie valutative che non potrebbero essere utilizzate nell’ambito della valutazione qui ipotizzata, poiché anche tali metodi presuppongono la continuazione dell’attività d’impresa. Da ultimo, evidenzia il Perito art. 84, che il metodo patrimoniale, nel caso in esame, pare contemperare due esigenze contrapposte: la prima consistente nella necessità di valutare il valore minimo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e la seconda esigenza rappresentata dalla necessità di garantire un valore congruo rispetto alle aspettative dei creditori muniti di privilegio su tali elementi patrimoniali.
Infine, anche in ordine alla stima del valore delle rimanenze di magazzino, Calzaturificio ha dato apposito mandato ad un perito. Quest’ultimo ha utilizzato come scenario di riferimento ai fini della redazione della propria perizia il valore in caso di liquidazione giudiziale. Ciò in quanto ha ritenuto non percorribile una vendita a normali condizioni di mercato poiché l’azienda non ha titolarità dei marchi e contrattualmente non ha alcun permesso alla vendita autonoma degli stessi. Il perito, inoltre, ha evidenziato come Calzaturificio adotta un metodo just in time, pertanto, una interruzione della produzione e quindi delle vendite dettata dalla necessità di ricorrere a procedure competitive, con conseguenti tempistiche prolungate, comporterebbe l’impossibilità di realizzare le vendite a condizioni di mercato. Tenuto conto di quanto sopra, il perito ha ritenuto che l’unica eventuale via percorribile per la cessione di tali beni sarebbe una vendita in stock, presso soggetti specializzati nel commercio all’ingrosso. Pertanto, sono state applicate specifici coefficienti di svalutazione per tipologia di rimanenza (dal 30% al 90%).
Il commissario giudiziale ha richiesto e ottenuto dal tribunale la nomina di un perito al quale è stato affidato l’incarico di verificare i valori indicati nelle perizie di stima allegate al ricorso, sopra sommariamente esposte per quanto di rilievo in questa sede, valutandone la congruità (verifica della congruità delle stime del compendio mobiliare e immobiliare della ricorrente)[310]. Complessivamente l’attività effettuata dal perito ha portato a ritenere congrui i valori assunti nel piano, pur con singoli valori differenti rispetto a quelli del perito nominato dalla Calzaturificio, dimostratesi, quest’ultimi, comunque superiori a quelli dell’ausiliario della procedura e conseguentemente più favorevoli al ceto creditorio. Pertanto, i valori assunti nel piano sono stati confermati e, quindi, fatti propri dall’ufficio commissariale.
d) Stima del valore di liquidazione delle azioni risarcitorie, recuperatore e revocatorie
Nel caso in esame, come si evince nel ricorso ex art. 40 CCII, è stata analizzata la sussistenza di profili di responsabilità gestoria, nonché di esercizio di azioni recuperatorie, non ravvisando tuttavia alcuna delle ipotesi suddette[311]. Ciò in quanto, ad avviso della ricorrente, Calzaturificio (i) è dotata di un coerente apparato organizzativo, amministrativo e contabile, (ii) gli amministratori hanno agito in modo informato nelle loro determinazioni, alla stregua dei principi codificati dall’art. 2381 c.c. e (iii) i bilanci sono stati redatti secondo corretti principi contabili; neppure si configurerebbero nei confronti dell’organo di controllo, avendo lo stesso invitato tempestivamente l’organo gestorio a presentare domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi. Ad avviso della ricorrente, Calzaturificio ha condotto ampia disclosure informativa sugli atti gestori e i fatti che hanno condotto la stessa ad affrontare una situazione di crisi; questi, ad avviso della ricorrente, non configurano alcun profilo di responsabilità in capo all’organo amministrativo e di controllo, nonché al revisore, stante l’operativa della c.d. business judgment rule, poiché in tale contesto è escluso che eventuali scelte gestorie possano essere sindacabili, tanto più in una prospettiva ex post.
L’attestatore, in ordine alle azioni risarcitorie, ha ritenuto che gli amministratori abbiano opportunamente presidiato i valori della continuità aziendale e si siano attivati tempestivamente con il ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi; lo stesso atteggiamento proattivo è stato constatato anche a livello produttivo, in quanto gli insediamenti produttivi esteri della Calzaturificio (siti in Romania e Serbia) sono sempre stati presidiati e non hanno mai interrotto la produzione. L’attestatore, prima ancora di valutare la possibile sussistenza di eventuali condotte che possano determinare una responsabilità, ha ritenuto di condurre una verifica sulla consistenza patrimoniale riferibile a ciascun amministratore e componente del collegio sindacale. Questo in quanto, evidentemente, la convenienza nell’esperibilità di un’azione di responsabilità dipende direttamente dalle prospettive di recupero di somme a favore della procedura. Peraltro, anche laddove esistessero profili di responsabilità in capo agli stessi, la convenienza nella esperibilità di eventuali azioni in caso di liquidazione giudiziale sarebbe da valutare alla luce dei tempi, non brevi, e dei costi per la procedura liquidatoria, non di lieve entità, considerato che la richiesta di un danno eventualmente attivata si potrebbe chiudere, come spesso accade, con una transazione fra le parti a valori ben inferiori alla pretesa. L’attestatore ha preliminarmente segnalato che le verifiche sulle consistenze patrimoniali dei componenti dell’organo amministrativo e dei sindaci effettuate si sono limitate a quelle effettuabili su banche dati pubbliche, attraverso l’estrazione di una visura catastale ed una visura ipotecaria per ciascun amministratore. Per valutare la capacità patrimoniale degli amministratori e dei sindaci, l’attestatore ha anche effettuato una ricerca in merito alle partecipazioni sociali eventualmente detenute in proprietà. Quanto ai tempi tecnici di realizzo dei beni in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, ovvero di liquidazione giudiziale, l’attestatore ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 10233/2015 che ha indicato in cinque anni “la durata ragionevole delle procedure fallimentari di media complessità”, termine “elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso”. In funzione di tali considerazioni, l’attestatore ha proceduto ad esaminare l’esistenza di eventuali condotte che possano legittimare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore, sulla base della lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’ultimo quinquennio; da tale lettura, l’attestatore ha concluso che non emergano atti compiuti tali da determinare motivi di responsabilità in capo agli stessi. I verbali del Consiglio di Amministrazione, infatti, ad avviso dell’attestatore sono sempre stati redatti in maniera completa e articolata, consentendo di rilevare come gli amministratori abbiano sempre cercato di agire in maniera “informata” ex art. 2381 c.c.
Sul tema, il commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 105 CCII ha evidenziato come non si ravvisino particolari censure all’organo amministrativo in quanto non sono emerse operazioni che possano ritenersi pregiudizievoli per i creditori dal momento che la crisi si è manifestata soprattutto per effetto di eventi imprevisti ed imprevedibili, e questa è stata affrontata dagli amministratori e dall’organo di controllo con tempestività facendo immediato ricorso ad uno degli strumenti previsti dalla normativa per la risoluzione della crisi d’impresa
Infine, in merito alle azioni revocatorie, ad avviso della ricorrente, non sono stati compiuti atti meritevoli di dichiarazione di inefficacia ex artt. 165 e 166 CCII, come anche confermato dall’attestatore e dal commissario giudiziale.
e) Stima del valore riservato ai soci
Al fine di adempiere al disposto di cui all’art. 120 quater CCII e tenuto conto della tipologia di concordato adottata (continuità diretta), la ricorrente ha provveduto alla stima del valore dell’azienda conseguentemente all’omologa, adoperando quale criterio di stima, il metodo del multiplo medio EV/EBITDA, che rappresenta, nelle operazioni di cessioni di società, il metodo più utilizzato per la valutazione d’azienda[312]. La ricorrente ritiene tale metodologia particolarmente adatta poiché consente di valutare, nel caso di specie, in ottica prospettica e sulla base della redditività attesa, il valore da poter attribuire all’azienda ad esito dell’omologazione del concordato. Per determinare l’equity value, ossia il valore netto dei soci, la ricorrente ha poi provveduto a decurtare dal valore ottenuto il fabbisogno concordatario, ossia il passivo che la società prevede di soddisfare con la proposta concordataria (e quindi nella misura falcidiata prospettata[313]. Il multiplo EV/EBITDA è stato ricavato dai dati pubblicati sul sito di A. Damodaran per analoghi settori in aziende europee. Ai fini della stima dell’EBITDA è stato assunto il valore attuale[314] della media degli EBITDA prospettici del piano; tale valore è stato moltiplicato per il multiplo del settore identificato. Tale multiplo, tuttavia, è stato ridotto del 50% per le seguenti ragioni:
- il multiplo fa riferimento ad aziende produttrici con marchio proprio, mentre la ricorrente produce per conto terzi e, pertanto, il proprio margine è inferiore rispetto alle aziende che producono con il proprio marchio;
- la società opera con 3/4 clienti, con evidente concentrazione del rischio e, conseguentemente, un eventuale cessione a terzi potrebbe non essere ben vista dai clienti che potrebbero anche decidere di interrompere la fornitura.
L’attestatore ha ritenuto che la ricorrente abbia correttamente effettuato le valutazioni dettate dal nuovo art. 120 quater, commi 1 e 2, CCII che ha condiviso sia in termini di impostazione logica, di criterio valutativo applicato che di risultanze finali, concernenti quello che deve considerarsi il “valore effettivo” riservato ai soci per effetto dell’eventuale omologa della proposta.
f) Focus – Regole di distribuzione del valore derivante dall’aumento di capitale sociale
La proposta di Calzaturificio prevede una operazione di aumento di capitale scindibile sospensivamente condizionato all’omologa del concordato preventivo[315]. Come si evince nel ricorso ex art. 40 CCII, l’apporto consente di avere flussi, assimilabili in tutto e per tutto ai flussi derivanti dalla continuità aziendale, che diversamente non si avrebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale. Tale valore viene considerato nel piano quale valore generato dalla continuità e quindi eccedente quello di liquidazione e, pertanto, assoggettabile non alla regola della priorità assoluta ma alla relative priority rule e non anche liberamente distribuibile in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. In altre parole, l’eccedenza rispetto al valore di liquidazione, generata tanto dai flussi della continuità e tanto dall’aumento di capitale, viene distribuita secondo la regola della priorità relativa. Ad avviso della ricorrente, la qualificazione dell’aumento di capitale in simili termini pare indirettamente ricavabile dal principio generale sancito dall’art. 84, comma 4, CCII secondo cui “si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”. La collocazione di tale principio nel comma relativo al concordato liquidatorio appare dettata unicamente dalla volontà del legislatore di “imporre” per la tipologia liquidatoria un apporto esterno, facoltativo invece per l’ipotesi di continuità.
g) Focus – Regole distribuzione del patrimonio con riferimento al trattamento dei debiti tributari e contributivi
A seguito del deposito della domanda di concordato preventivo, il tribunale ha richiesto, ai sensi dell’art. 47 CCII, al debitore taluni chiarimenti, tra cui, in parte qua, precisazioni in merito alle regole di distribuzione del patrimonio con riferimento al trattamento dei crediti tributari e previdenziali. In particolare, il tribunale ha evidenziato che l’art. 88, comma 1, ultimo periodo, CCII così stabilisce “Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”. Pare chiaro in base all’interpretazione letterale, ad avviso dei giudici di merito, che i crediti erariali chirografari non possano avere un trattamento deteriore rispetto a nessun’altra classe, sicché devono avere un trattamento almeno pari alla classe destinataria della percentuale più favorevole. Non è previsto in particolare che essi possano avere un trattamento deteriore rispetto ai creditori degradati che ab origine godevano di un privilegio di grado superiore: il legislatore ha riservato una disciplina “rinforzata” ai crediti tributari o contributivi di natura chirografaria (tali divenuti “anche a seguito di degradazione per incapienza” come ha aggiunto l’art. 3 del D.L. 7 ottobre 2020) (cfr. Cass. ord. n. 17155/2022 Est. Vella). Trattasi di una regola distributiva speciale rispetto alla c.d. Relative Priority Rule di cui all’art. 84, comma 6, CCII, dettata nell’ottica di favorire i crediti erariali, dunque destinata ad applicarsi anche all’attivo derivante dal c.d. surplus da continuità aziendale. Nel piano invece i crediti erariali chirografari sono stati inseriti in due distinte classi, a seconda del grado di privilegio, con previsione di soddisfazione deteriore rispetto alla classe I.
La ricorrente ha precisato come l’iniziale impostazione adottata con riferimento al trattamento dei crediti contributivi e fiscali era basata su di una diversa interpretazione della norma, secondo cui l’art. 88 CCII, nella parte richiamata dal provvedimento, si applicherebbe al solo concordato liquidatorio. L’incipit dello stesso art. 88 CCII reca un dato letterale, ad avviso della ricorrente, significativo: “Fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall’art. 112, comma 2 (…)”. Alla luce di ciò, ad avviso della ricorrente, può fondatamente ritenersi che nel concordato in continuità aziendale il disposto degli artt. 84, comma 6, e 112, comma 2, lett. b) CCII prevalga su quello previsto all'art. 88, comma 1, ultimo periodo CCII, relativamente ai crediti privilegiati assistiti da privilegio generale e degradati a chirografo per incapienza. Inizialmente, per tali ragioni, la Calzaturificio aveva ritenuto che la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 1 art. 88 CCII fosse applicabile al solo concordato liquidatorio, motivo per il quale nella formazione delle classi costituite da crediti privilegiati degradati a chirografo di Agenzia dele Entrate, INPS e INAIL aveva seguito uno schema che ricalcava la graduazione delle cause legittime di prelazione sebbene in applicazione della c.d. Relative Priority Rule. Nonostante ciò, la ricorrente ha preso atto della diversa interpretazione del Tribunale e ha proceduto alla modifica delle percentuali di riparto e della formazione delle classi.
- la società è dotata d’un coerente apparato organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla struttura imprenditoriale;
- gli amministratori hanno agito in modo informato nelle loro determinazioni, alla stregua dei principi codificati nell’art. 2381 c.c.;
- i bilanci sono stati redatti secondo corretti principi contabili.
Sul tema, anche l’attestatore non ha ravvisato i presupposti per l’esercizio di azioni risarcitorie, recuperatore e revocatorie.
a) Sintesi della società, delle cause della crisi e tipologia di concordato
- benché prudentemente la richiesta di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il ramo d’azienda, non può sottacersi che il piano concordatario si basi sostanzialmente sull’intervento del terzo, evidentemente interessato alla chiusura positiva della presente vicenda concordataria, che intende rendersi acquirente dalla azienda almeno a valori di perizia ed immettere finanza esterna al fine di sostenere la proposta concordataria;
- il commissario giudiziale ha espresso un parere favorevole in ordine a quanto richiesto, affermando che, al fine di eguagliare nella sostanza le somme messe a disposizione del terzo complessivamente, sarebbe necessario che in asta l’azienda fosse aggiudicata ad un valore superiore a detta somma complessiva.
d) Il valore di liquidazione, la prosecuzione temporanea dell’attività e l’esercizio provvisorio
Come sopra accennato, il piano concordatario prevede la prosecuzione diretta dell’attività d’impresa da parte di Respitalia sino al momento in cui, previa autorizzazione da parte del Tribunale, provvederà alla cessione al terzo che ha formulato offerta irrevocabile nonché all’eventuale diverso aggiudicatario. A seguito del deposito del ricorso ex art. 40 CCII, il Tribunale ha richiesto taluni chiarimenti, tra cui quanto segue: ai fini della corretta allocazione del profitto della gestione caratteristica maturato sino alla cessione del ramo aziendale, dovrebbe considerarsi se, in uno scenario liquidatorio, sarebbe percorribile l’ipotesi di un esercizio provvisorio o meno, essendo nel primo caso i ricavi parte del valore della liquidazione, nel secondo caso da considerarsi, viceversa, quale valore eccedente la liquidazione stessa, posto che né il piano, né l’attestazione né il parere del commissario giudiziale prendono esplicita posizione su quanto sopra considerato[330].
Ad esito di tale richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha confermato che il valore di liquidazione tiene conto di quanto indicato dal Tribunale, tenuto conto che esso include i flussi derivanti dall’esercizio provvisorio e, in particolare, (i) il corrispettivo della cessione del ramo aziendale e (ii) il valore attuale netto dei flussi finanziari derivanti dalla gestione che va da deposito della domanda con riserva alla cessione del ramo aziendale.
e) Le regole distributive dell’apporto di risorse esterne
Il terzo che ha formulato una offerta irrevocabile di acquisto si è altresì impegnato ad apportare una somma a titolo di apporto esterno[331]. L’apporto, si legge nel ricorso ex art. 40 CCII, è intimamente connesso alla assoluta necessità, per il terzo, di evitare qualsivoglia rischio – altrimenti non del tutto eludibile – di interruzione anche solo temporanea del servizio di assistenza ai pazienti disabili ospitati presso la RSD ove viene svolta l’attività del ramo aziendale di interesse. A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento motivazionale che ha indotto il terzo ad offrire l’apporto, anche il fatto che solo un trasferimento in capo al terzo stesso della proprietà del ramo aziendale senza alcuna soluzione di continuità è atto a preservare il rischio, per il terzo, di vedersi oggetto di pretese creditorie da parte dei creditori di Respitalia e, in particolare, dei dipendenti.
Sul punto dell’apporto di risorse esterne, Respitalia ha sottolinato (i) l’assoluta estraneità e neutralità rispetto al patrimonio di Respitalia della provvista da destinarsi a beneficio dei creditori concorsuali a titolo di “finanza esterna (ii) il fatto che la predetta “finanza esterna” non perverrà nelle disponibilità dirette (e, quindi, nel patrimonio) di Respitalia, bensì sarà rimessa direttamente nella disponibilità dei creditori concorsuali, giusta corresponsione in favore del Commissario Giudiziale, secondo le modalità che saranno stabilite dal Tribunale con il provvedimento di omologazione, (iii) il fatto che, a fronte dell’apporto della “finanza esterna”, nessuna controprestazione viene richiesta a Respitalia, tant’è che tutti gli attivi ulteriori di Respitalia saranno destinati, nelle forme di cui si è già dato conto, al beneficio esclusivo dei creditori concorsuali, così come ogni eventuale sopravvenienza attiva realizzata anche in corso di procedura sarà parimenti destinata al soddisfacimento del ceto creditorio concorsuale.
Tenuto conto di quanto sopra indicato, Respitalia ha ritenuto di condividere l’interpretazione secondo la quale anche nel concordato in continuità l’apporto esterno, come definito sopra, possa essere distribuito liberamente senza dover sottostare neppure alla regola della priorità relativa, tenuto conto che il piano di concordato ne prevede l’utilizzo per il pagamento della totalità dei debiti maturati nei confronti di erario ed enti previdenziali. Ad avviso della ricorrente, infatti, la finanza esterna non è una componente del valore di liquidazione, ma conserva una propria autonomia e caratteristiche tali che consentono di utilizzarla con criteri di discrezionalità anche in deroga al rispetto dell’Absolute priority rule e della Relative priority rule.
Sul punto, tenuto conto dell’avvenuta emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo ove si evince il libero utilizzo della finanza esterna, si desume che il Tribunale abbia condiviso la tesi esposta da Respitalia.
f) Stima del valore di liquidazione delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie
Nel ricorso ex art. 40 CCII, la ricorrente ha ampiamente evidenziato gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’organo gestorio nell’ultimo quinquennio, nonché operazioni potenzialmente rilevanti[332]. La ricorrente ha concluso ritenendo che non si sia in presenza di alcun tipo di operazioni straordinarie – né, tanto meno, di atti di illecita disposizione del patrimonio, ovvero di atti esulanti l’oggetto e l’interesse sociale – che possano costituire oggetto di autonoma censura, avendo, piuttosto, l’amministratore di Respitalia cercato di fare buon governo dei propri doveri di diligente gestione del patrimonio sociale. Inoltre, ha evidenziato la ricorrente che nel caso di specie le operazioni poste in essere non ha causato un aggravio dell’indebitamento, ma anzi hanno determinato un miglioramento della cassa, ben potendo, dunque, essere considerati come atti negoziali profittevoli.
In ogni caso, conclude la ricorrente, a fronte dei risultati ottenibili per effetto dell’adempimento delle obbligazioni concordatarie, l’eventuale azione nei confronti dell’amministratore unico risulterebbe, con buona probabilità e nell’ipotesi (ritenuta del tutto ipotetica e comunque contestata) in cui questa dovesse avere esito positivo, in ogni caso priva di concreta utilità, attesa la modesta consistenza del patrimonio immobiliare dell’amministratore unico.
Sul tema anche l’attestatore ha ritenuto che, ad esito delle verifiche svolte è possibile rilevare ragionevolmente che nessuna delle operazioni straordinarie descritte nella relazione ex art. 39, c. 2, CCII, abbia rappresentato un atto pregiudizievole per i creditori. Quanto alle azioni revocatorie, l’attestatore ha condiviso l’esame svolta dalla ricorrente che ha quantificato le utilità potenzialmente rinvenibili dall’esperimento di azioni revocatorie, al netto delle spese legali e delle ragionevoli tempistiche per pervenire ad un giudicato.
1. stima del valore di liquidazione in sede giudiziale ipotizzando la cessione in sede di terzo esperimento di vendita, da concludersi entro un anno dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 216, comma 2, CCII;
2. determinazione dei frutti civili, di cui all’art. 223 CCII, i quali sono stati stimati sino all’alienazione degli immobili ipotizzata in un anno dall’apertura della procedura liquidatoria, come indicato al punto precedente;
3. determinazione delle spese di procedura della liquidazione giudiziale, senza considerare le spese professionali maturate nell’ambito della procedura concrdataria, e attribuzione delle stesse alla massa immobiliare;
4. determinazione del valore di liquidazione al netto delle spese presumibilmente sostenibili in sede di liquidazione giudiziale.
c) Le regole distributive dell’apporto di risorse esterne
Nel ricorso si evince che l’amministratore unico ha messo a disposizione della procedura, condizionatamente all’omologazione definitiva del concordato preventivo, una somma a titolo di finanza esterna[336]. A tal proposito, la ricorrente ha sottolineato (i) l’assoluta estraneità e neutralità rispetto al patrimonio di Terdoppio della provvista da destinarsi a beneficio dei creditori concorsuali a titolo di “finanza esterna”, (ii) il fatto che la predetta “finanza esterna” non perverrà nelle disponibilità dirette (e, quindi, nel patrimonio) della Terdoppio, bensì sarà rimessa direttamente nella disponibilità dei creditori concorsuali, giusta corresponsione in favore del commissario giudiziale, secondo le modalità che saranno stabilite dal Tribunale con il provvedimento di omologazione della proposta di concordato, (iii) il fatto che, a fronte dell’apporto della “finanza esterna”, nessuna controprestazione viene richiesta a Terdoppio.
Tenuto conto di quanto sopra indicato, Terdoppio ha ritenuto di condividere l’interpretazione secondo la quale anche nel concordato in continuità l’apporto esterno, come definito sopra, possa essere distribuito liberamente senza dover sottostare neppure alla regola della priorità relativa, tenuto conto che il piano di concordato ne prevede l’utilizzo per il pagamento della totalità dei debiti maturati nei confronti di erario ed enti previdenziali.
Sul punto, tenuto conto dell’avvenuta emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo ove si evince il libero utilizzo della finanza esterna, si desume che il Tribunale abbia condiviso la tesi esposta da Terdoppio.
d) Stima del valore di liquidazione delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie
Nel ricorso ex art. 40 CCII, la ricorrente ha ampiamente evidenziato gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’organo gestorio nell’ultimo quinquennio, nonché operazioni potenzialmente rilevanti[337]. La ricorrente ha concluso ritenendo che non si sia in presenza di alcun tipo di operazioni straordinarie – né, tanto meno, di atti di illecita disposizione del patrimonio, ovvero di atti esulanti l’oggetto e l’interesse sociale – che possano costituire oggetto di autonoma censura, avendo, piuttosto, l’amministratore di Terdoppio cercato di fare buon governo dei propri doveri di diligente gestione del patrimonio sociale. Prova di ciò, ad avviso della ricorrente, è il fatto che ogni diversa condotta avrebbe portato al definitivo naufragare delle iniziative immobiliari, così arrecando un danno definitivo ed irreparabile che, invece, è stato comunque evitato essendo oggi la Terdoppio nella disponibilità di immobili comunque ben valorizzati dal perito e sulla cui base il piano contempla la valorizzazione di detti immobili e la loro utilizzabilità ai fini del ristoro dei relativi creditori ipotecari altrimenti del tutto compromesso.
Sul punto, l’attestatore dopo una analisi dei bilanci degli ultimi cinque esercizi, sui quali ha apportato talune rettifiche, ha concluso ritenendo che tali rettifiche non incidono sulla patrimonializzazione della Terdoppio in misura tale da dover attivare i doveri di ricapitalizzazione o liquidazione.
Quanto alle azioni revocatorie, l’attestatore, in prima istanza, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio di cui all’art. 166, comma 2, CCII in considerazione del fatto che, tra gli altri, si evince dalla visura camerale l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c., rendendo quindi pubblico lo stato di crisi della società. Pertanto, l’attestatore ha verificato i pagamenti effettuati nel periodo sospetto ed è giunto alla determinazione del valore da assegnare alle utilità rinvenibili da possibili azioni revocatorie, al netto delle relative spese presumibili, che è stato incluso nel valore di liquidazione.
- la temporanea prosecuzione dell’attività propedeutica alla cessione in esercizio dei rami d’azienda, per uno dei quali è pervenuta una offerta di acquisto, mentre per l’altro la società è in attesa di ricevere l’offerta di un terzo già individuato;
- la liquidazione di tutti gli altri asset aziendali non ricompresi nei rami di cui sopra;
- l’apporto di finanza esterna da parte di un terzo.
b) Il valore di liquidazione, la comparazione con lo scenario della liquidazione giudiziale e l’offerta di acquisto
Il caso in esame che, come anticipato, concerne una proposta di concordato semplificato assume valenza nel tema che viene qui affrontato in quanto viene esaminato in modo molto puntuale la stima del valore in caso di liquidazione giudiziale, nonché affronta la tematica, sulla quale il tribunale ha altresì preso posizione[339], relativa alla ricezione di una offerta di acquisto a valori maggiori rispetto al valore di perizia[340].
In primo luogo, come si evince nel ricorso ex art. 25 sexies CCII, al fine di supportare le analisi compiute dalla ricorrente, è stato richiesto ad un perito incaricato di individuare - oltre ai valori negli scenari di continuità diretta e di liquidazione atomistica - anche la stima del valore atteso in caso di vendita unitaria del complesso aziendale in condizioni di “consolidata assenza di operatività aziendale”. Tale distinto scenario valutativo verrà assunto, ai fini del ricorso, come quello in cui simulare lo svolgimento della liquidazione giudiziale da porre a confronto con lo scenario di concordato semplificato. La ricorrente ritiene, infatti, in ottica massimamente prudenziale di non simulare una disgregazione atomistica del compendio aziendale nella liquidazione giudiziale, quale termine di confronto con il soddisfo atteso nella proposta di concordato semplificato. In altre parole, il perito ha prodotto i valori di stima sia nell’ipotesi di realizzo di mercato, sia in quella liquidatoria: per quella liquidatoria, relativamente ai beni mobili (essenzialmente gli impianti e le attrezzature), ha espresso valori in una duplice ipotesi subordinata: i) quella della liquidazione atomistica; ii) quella del complesso di beni in ottica sinergica, in quanto intesi ancora come sistemi produttivi organizzati, ancorché in temporanea interruzione della produzione. Quest’ultimo valore è stato assunto dalla società ai fini comparativi e, pertanto, per la stima del valore di liquidazione in caso di apertura della liquidazione giudiziale (valore che, come indicato in seguito, è inferiore rispetto al prezzo offerto per l’acquisto da parte del terzo).
Il perito ha proceduto applicando al più probabile valore di liquidazione complessivo dei beni oggetto di stima (inteso come il valore nello scenario di liquidazione c.d. atomistica) un incremento di valore per ogni singolo bene in funzione delle specifiche caratteristiche dei beni e del mercato di riferimento, con particolare valutazione dei seguenti aspetti:
1. nel caso di vendita unitaria del compendio aziendale in condizioni di consolidata assenza di operatività aziendale, i costi e gli oneri per la rimozione/disinstallazione ed eventuale reinstallazione dei beni in altro sito produttivo, risultano sostanzialmente non considerabili e/o sensibilmente ridotti, in quanto si ipotizza che i beni stessi possano riprendere l’attività e la funzionalità senza oneri di rimessa in esercizio così elevati come nel caso di vendita forzata di ogni singolo bene. Tale considerazione conduce comunque ad un migliore apprezzamento sul mercato dei beni stessi, rispetto allo scenario di liquidazione c.d. atomistica;
2. in tale scenario deve comunque essere considerata una riduzione della possibile appetibilità di mercato dei beni stessi, la cui entità dipende da condizioni oggettive peculiari del compendio aziendale oggetto di valutazione, dovendosi concludere che nello scenario di consolidata assenza di operatività aziendale il valore attribuibile al compendio aziendale può essere ricollegato a vari fattori tanto generici che peculiari del compendio aziendale oggetto di valutazione[341], che conducono ad una restrizione della “domanda” potenziale riducendola ad un limitato gruppo di possibili acquirenti disposti a pagare denaro per acquistare i beni nella situazione descritta (quella di consolidata assenza di operatività aziendale).
In funzione di tali aspetti, il perito ritiene quindi che nella prospettiva di cessione ed in uno scenario di consolidata assenza di operatività aziendale, possa attribuirsi un valore leggermente superiore a quello determinato nello scenario di liquidazione c.d. atomistica, seppure considerevolmente inferiore a quello determinato nello scenario di continuità aziendale. Infatti, ai fini dell’analisi comparativa per la verifica dell’assenza di pregiudizio per i creditori, la società ricorrente ha proposto un raffronto basato proprio su questo (maggior) valore di liquidazione del compendio dell’attivo rappresentato dai beni mobili, in termini di complesso produttivo organizzato.
L’ausiliario nominato dal tribunale nell’ambito della omologazione del concordato semplificato ha condiviso questa opzione metodologica, sia perché più rispondente alla effettiva situazione dei beni della società sia in quanto rispettosa del principio di economicità dei beni, il quale costituisce un solido principio logico della valutazione del patrimonio aziendale, che interpreta i beni non come singoli elementi, ma come combinazione produttiva maggiormente valorizzata in virtù dell’azione organizzativa impressa dall’imprenditore. Inoltre, come si evince nel parere dell’ausiliario, il perito ha sviluppato una più complessa metodologia di valutazione per i beni mobili, in ragione della loro complementarità strumentale nei processi produttivi della società e quindi della loro attitudine a conservare valore, anche in sede di liquidazione, diversamente e in misura superiore ad una mera liquidazione atomistica. Tale metodologia di valutazione, ad avviso dell’ausiliario, è maggiormente fedele alla realtà fattuale[342] e più coerente rispetto all’espressione di un giudizio in ordine alla valutazione comparativa del realizzo in sede di concordato semplificato con l’alternativa della liquidazione giudiziale. Una valutazione che consideri la natura “sistemica” dei complessi produttivi, oggettivamente superiore a quella di una mera valutazione in sede liquidatoria atomistica, apprezza un maggiore valore e quindi viene a costituire un parametro di raffronto più prudenziale in termini di possibile (maggiore) valore differenziale dell’esito della liquidazione concordataria. Questo approccio metodologico è stato adottato effettivamente dalla ricorrente e appare condiviso dall’ausiliario, anche e soprattutto nell’ottica della tutela dei creditori.
Per i beni oggetto di maggior valore ed importanza per i quali sono noti i valori di acquisto e l’anzianità dei beni stessi, il perito ha proceduto ad una valutazione mediante metodo del costo, basato sull’ipotetico valore “a nuovo” dei beni fornito/indicato dal committente, al quale è stato applicato un coefficiente correttivo legato all’obsolescenza dei beni stessi. Per i beni di minor valore e/o con un più ampia diffusione sul mercato di riferimento e/o in assenza di informazioni sulla vetustà, il perito ha proceduto con una valutazione mediante metodo diretto di comparazione con il valore di beni similari a quelli oggetto di stima e di cui siano noti i valori di mercato e/o liquidazione.
Con riferimento al valore delle partecipazioni detenute da Doplà, il perito ha adottato un metodo misto di determinazione autonoma dell’avviamento, stante la presenza di un business plan della società valutata. La valutazione è stata condotta ipotizzando una vendita coattiva nell’ambito di una procedura d’asta, con applicazione di uno sconto del 50%. Sul punto, l’ausiliario ha evidenziato come il perito non abbia applicato alcuno “sconto di illiquidità”. Invero, le azioni della società oggetto di valutazione non sono quotate in mercati regolamentati e quindi subiscono gli effetti di difficoltà di commercializzazione, prestandosi pertanto a concrete ipotesi di applicabilità del cosiddetto “sconto di illiquidità”, dovuto per l’appunto alle difficoltà di realizzabilità.
Premesso quanto sopra, il perito è giunto a determinare, per taluni asset (in particolare, il portafoglio marchi, i beni mobili di alcuni rami aziendali e le rimanenze), un valore inferiore rispetto a quello per i quali sono pervenuto offerte di acquisto da parte di terzi; in funzione di tale valutazione, la ricorrente ha stimato il valore di liquidazione giudiziale sulla base del (minor) valore stimato dal perito e non sulla base dell’offerta di acquisto pervenuta. Sul tema, l’ausiliario ha dato atto che i valori dei beni mobili e immobili e rimanenze assunti come parametro di riferimento per la determinazione del valore di liquidazione nello scenario della liquidazione giudiziale sono i minori valori delle perizie rispetto ai maggiori valori derivante dalle offerte di acquisto pervenute. Nello specifico, precisa l’ausiliario che, in conseguenza all’attività liquidatoria forzata, nella liquidazione giudiziale dovranno essere liquidati i beni di proprietà della società sulla base delle stime effettuate dal perito a valori prevalentemente assai inferiori (rispetto a quanto previsto dal concordato semplificato in presenza delle offerte di acquisto) e con tempistiche incerte[343].
Sul tema della corretta determinazione del valore di liquidazione in presenza di una offerta di acquisto a valori maggiori rispetto a quelli di stima, in sede di giudizio di omologazione un creditore eccepisce che, non essendo l’offerta del terzo per l’acquisto di uno dei rami aziendali (comprensivo dei beni mobili e delle rimanenze ad esso afferenti) subordinata all’omologa ma solo alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta (si presume, ipotizzata durante il percorso della composizione negoziata), la comparazione tra i due scenari (liquidazione giudiziale e concordato preventivo) doveva tener conto dello stesso valore di realizzazione per tale ramo e non, invece, il minor valore di perizia assunto come riferimento nella stima dello scenario di liquidazione giudiziale da parte della ricorrente. Il Tribunale ha statuito che “Il motivo non può trovare accoglimento perché la stima del valore dell’azienda nello scenario liquidatorio, pur considerando la vendita unitaria e non atomistica in coerenza con quanto dispone l’art. 214 comma 1 CCI, deve avvenire con riferimento alla data di apertura del concorso. La vendita del Ramo è avvenuta nel contesto della soluzione concordataria ed è il risultato della negoziazione tra le parti condotta successivamente alla composizione negoziata e in funzione della domanda di concordato. Non vi è alcuna evidenza che … [il terzo] avrebbe acquistato l’azienda e alle medesime condizioni anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale”.
Infine, con riferimento alla correttezza della metodologia di stima adottata dalla società, e condivisa dall’ausiliario, che si basa sulla ipotesi di prospettiva di cessione in uno scenario di consolidata assenza di operatività aziendale che, come sopra esposto, conduce ad un valore leggermente superiore a quello determinato nello scenario di liquidazione c.d. atomistica seppure considerevolmente inferiore a quello determinato nello scenario di continuità aziendale, si è espresso in modo puntuale il Tribunale ad esito della opposizione formulata da un creditore. In particolare, il creditore opponente ha eccepito la carenza informativa nella proposta di concordato semplificato e nei pareri dell’ausiliario e dell’esperto in ordine al surplus che potrebbe derivare da un eventuale “prevedibile” esercizio provvisorio da parte del curatore. Il Tribunale ha statuito che lo scenario dell’esercizio provvisorio risulta “solo ipotetico tenuto conto della complessità gestionale di un’impresa con quasi 200 dipendenti strutturata su stabilimenti con linee di produzione diverse, rilevanti costi fissi, di valori di EBITDA negativi per quasi tutto il corso del procedimento e dell’assenza di soluzioni diverse dall’offerta … per la cessione dell’azienda in esercizio oggetto di specifica verifica da parte dell’Ausiliario”. Inoltre, precisano i giudici di merito che in “assenza di un’offerta, non vi è alcuna evidenza che l’esercizio provvisorio non arrechi pregiudizio ai creditori come richiesto dall’art. 211 comma 2 CCI anzi gli elementi desumibili dalle relazioni dell’Ausiliario, che ha verificato tutti gli aspetti dell’azienda e della sua crisi … dimostrano che vi è un’alta probabilità che il prolungarsi dell’attività d’impresa determini un sensibile aumento dei crediti prededucibili”. Con specifico riferimento al criterio di valorizzazione adottato dalla società e condiviso dall’ausiliario, il Tribunale ha rimarcato che “lo scenario della liquidazione giudiziale preso dalla Ricorrente quale termine di confronto con gli altri scenari non si riferisce alla liquidazione atomistica dell’attivo ma alla vendita unitaria del complesso in ipotesi di “consolidata assenza di operatività aziendale”, in coerenza con il disposto di cui all’art. 214 comma 1 CCI e in una prospettiva, quindi, di maggior garanzia per i creditori”. Concludono, infatti, i giudici di merito evidenziando che il perito incaricato aveva espresso, nell’ipotesi liquidatoria, due valori, quello della liquidazione atomistica e quella del complesso dei beni in un’ottica sinergica, intesi ancora come sistemi produttivi organizzati se pur in temporanea interruzione della produzione e “la società in via prudenziale ha adottato il secondo criterio di stima che attribuisce un maggior incremento al valore di liquidazione”.
M. Arato, Il concordato preventivo, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto da Cagnasso-Panzani, Milano, 2025
M. Arato, Il piano di concordato e soddisfazione dei creditori concorsuali, in Crisi d’Impresa e procedure concorsuali, diretto da Cagnasso-Panzani, Milano, 2016
A. Auricchio, G. Covino, L. Jeantet, P. Vallino, Absolute e relative priority rule a confronto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in IUS Crisi d’impresa, 6 ottobre 2022
K. Ayotte, E.R. Morrison, Valuation Disputes in Corporate Bankruptcy, in Columbia Law School, 2018 D.G. Baird, Priority Matters: Absolute Priority, Relative Priority, and the Costs of Bankruptcy, in University of Pennsylvania Law Review, 2017
G. Ballerini, Art. 160, comma 2°, l. fall. (art. 85 c.c.i.i.), surplus concordatario e soddisfazione dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2021 G. Ballerini, Le riorganizzazioni societarie fra absolute e relative priority rule, Torino, 2023
G. Ballerini, Le ricadute di diritto italiano della regola di non discriminazione nella Direttiva Insolvency, in Giurisprudenza Commerciale n. 5-2021
A. Bassi, La “finanza esterna” nel concordato preventivo tra finanziamento del debitore e finanziamento della iniziativa, in Giur. comm., 2019, I
D. Vattermoli, La posizione dei soci nelle ristrutturazioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine, in Riv. Società, 2018
P. Benazzo, Gli strumenti di regolazione della crisi delle società e i diritti “corporativi”: che ne resta dei soci?, in Dirittodellacrisi.it, 4 dicembre 2023
M. Binelli, L’omologazione del concordato in continuità non approvato, in Dirittodellacrisi.it, 27 dicembre 2022
M. Bini, Le valutazioni nelle crisi e nelle situazioni di insolvenza delle imprese, in Valutazione imprese in crisi, I/luglio 2019
M. Bini, Principi e formula generale di valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza, in Valutazione imprese in crisi, III/luglio 2020
M. Bini, La valutazione d’azienda a fini di una liquidazione forzata in asta, in Valutazione imprese in crisi, III/luglio 2020
G. Bozza, Le vendite nella liquidazione giudiziale, Il Fall. n. 10/2023
G. Bozza, Il trattamento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Il Fall., 2012
F. Buttignon, La valutazione delle imprese in crisi finanziaria, in Valutazione imprese in crisi, II/dicembre 2019
P.G. Cecchini, Il valore riservato ai soci nel concordato: una norma in bianco e nero da interpretare in grigio”, in IUS Crisi d’impresa, 21 febbraio 2024
R. Damman, M. Gerrer, The transposition of the EU directive on early corporate restructuring and second chance into french law, in Revista General de Insolvencias & Reestructuraciones, n. 5/2022
G. D’Attorre, Concordato con continuità ed ordine della causa di prelazione, in Giur. comm., 2016, I
G. D’Attorre, La distribuzione del patrimonio del debitore tra absolute priority rule e relative priority rule, in Il Fall. n. 8-9/2020,
G. D’Attorre, Le regole di distribuzione del valore, in Il Fall. n. 10-2022, pp. 1223 ss
G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2022
G. D’Attorre, Relative priority rule(s), in D. Vattermoli (a cura di) La questione distributiva nel diritto della crisi e dell’insolvenza, Pisa, 2023
P. De Cesari, Al via in Spagna la nuova “reforma concursal”, in Il Fall., 2/2023
F. Di Marzio (a cura di), Diritto dell’insolvenza, Milano, 2023
D.C. Ehmke, J.L.L. Gant, J.M.G.J. Boon, L. Langkjaer, E. Ghio, The European Union preventive restructuring framework: A hole in one?, in International Insolvency Review, gennaio 2019, p. 7
M. Engelberg, A theory of relativity in restructuring developed with the Coase Theorem, in International Insolvency Review, luglio 2023
M. Fabiani (a cura di), Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, Roma, 2023
M. Fabiani, Effetti dell’autonomia del Diritto della Crisi tra un breve catalogo dei principi e delle clausole generali e il nuovo lessico del Codice, in Dirittodellacrisi.it, 5 ottobre 2023
M. Fabiani, Un affresco sulle nuove 'milestones' del concordato preventivo, in Dirittodellacrisi.it, 6 ottobre 2022
M. Fabiani, L’avvio del codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 5 maggio 2022
M. Fabiani, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2017
M. Fabiani, La rimodulazione del dogma della responsabilità patrimoniale e la de-concorsualizzazione del concordato preventivo, in IlCaso.it, 9 dicembre 2016
M. Fabiani, Fallimento e concordato preventivo, II, Concordato preventivo, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, 2014
M. Fabiani, A. Guiotto, Il valore della ristrutturazione destinabile ai soci, in Il Fall. n. 5/2024
M. Fabiani, S. Leuzzi, Il controllo giudiziale nei concordati – La ristrutturazione trasversale, in Dirittodellacrisi.it, 18 dicembre 2024
M. Fabiani, I. Pagni, I giudizi di omologazione nel Codice della Crisi, in Dirittodellacrisi.it, 31 agosto 2022
M. Fabiani, I. Pagni, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in Il Fall., n. 8/2022
F. Fimmano’, L’affitto di azienda preesistente nel codice della crisi, in Giurisprudenza Italiana, Luglio 2023
D. Galletti, Portata e razionalità economica dell’absolute priority rule, in D. Vattermoli (a cura di) La questione distributiva nel diritto della crisi e dell’insolvenza, Pisa, 2023
L. Gambi, Il valore di liquidazione nel concordato preventivo, IUS Crisi d’impresa, 30 marzo 2023
F. Garcimartin, The Spanish Approach to Corporate Restructuring: A “Pre-packaged Chapter 11”, in European Insolvency and Restructuring Journal, 6/2022
B. Grohsgal, How Absolute Is the Absolute Priority Rule in Bankruptcy? The Case for Structured Dismissals, in volume 8 William and Mary Business Law Review, 2017
F. Guerrera, Struttura finanziaria, classi dei creditori e ordine delle prelazioni nei concordati delle società, in Dir. fall., 2010, I
A. Guiotto, Il valore riservato ai soci nel concordato in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 13 aprile 2023
M. Greggio, M. Razzino, Il valore di liquidazione dei beni: brevi considerazioni basate su osservazioni empiriche, in Dirittodellacrisi.it, 23 aprile 2024
J.R. Hall, A Creditor’s Kerfuffle: How the SBRA Harms Cr fuffle: How the SBRA Harms Creditors in Small ors in Small Business Cases, North Caroline Banking Institute, v. 25, 2021
B. Inzitari, Le mobili frontiere della responsabilità patrimoniale: distribuzione del valore tra creditori e soci nel concordato in continuità secondo la negozialità concorsuale del codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 27 febbraio 2023
E.J. Janger, The U.S. Small Business Bankruptcy Amendments: A Global Model for Reform?, Brooklyn Law School, 2020
L. Jeantet, S. Midolo, M. Pollio, P. Vallino, Valore di realizzo dei diritti risarcitori nell’alternativo scenario della liquidazione giudiziale: il non semplice confronto tra stima e migliore soddisfazione dei creditori e le evidenze non proprio empiriche, in Dirittodellacrisi.it, 22 marzo 2024
I. Kokorin, S. Madaus, I. Mevorach, Global Competition in Cross-Border Restructuring and Recognition of Centralized Group Solutions, in Texas International Law Journal, 2021 A. Krohn, Rethinking priority: The dawn of the relative priority rule and the new “best interests of creditors” test in the European Union, in International Insolvency Review, novembre 2020
F. Lamanna, “Valore di liquidazione” e “valori eccedenti” nel concordato preventivo: come calcolarli e distribuirli, in IUS Crisi d’impresa, 13 ottobre 2023
F. Lamanna, Il Codice della crisi e dell’insolvenza dopo il secondo correttivo, Milano, 2022
F. Lamanna, “Definitività” della degradazione al chirografo dei crediti privilegiati incapienti, in Il Fallimentarista, 12 maggio 2014
G. Lener, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa), in Dirittodellacrisi.it, 25 febbraio 2022
A.M. Leozappa, Sul “valore eccedente quello di liquidazione” nel concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, comma 6, CCII), in Dirittodellacrisi.it, 3 marzo 2025
S. Leuzzi, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo: oggetto, regole, controlli, in Dirittodellacrisi.it, 9 ottobre 2023
S. Leuzzi, L’esercizio (non più provvisorio) dell’impresa del debitore nel quadro del codice della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 31 marzo 2019
G.P. Macagno, La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità, in Dirittodellacrisi.it, 6 aprile 2022
F. Macario, Il concorso dei creditori nell’evoluzione della responsabilità patrimoniale: appunti per una riflessione tra diritto generale delle obbligazioni e nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 10 marzo 2025
S. Madaus, Is the Relative Priority Rule right for your jurisdiction? A simple guide to RPR, in Stephan Madaus Blog, January 18, 2020
A. Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, Milano, 2023
T. Mastrullo, Between modernity and prudence: the transposition into French law of Directive (EU) 2019/1023 of 20 June 2019 on restructuring and insolvency, in European Insolvency and Restructuring Journal Academic Article, 2022-4
G. McCormack, The European Restructuring Directive and stays on creditor enforcement actions, in International Insolvency Review, luglio 2021
G. McCormack, Debt restructurings, debt grifting and the limits of contractualism, in International Insolvency Review, agosto 2023
R. Mokal, Fairness, in Lorenzo Stanghellini, Rizwaan Mokal, Christoph Paulus (a cura di), Best Practices in European Restructuring: Contractualised Distress Resolution in the Shadow of the Law, Milano, 2018
R. Mokal, The court’s discretion in relation to the Pt 26A cram down, in Journal of International Banking and Financial Law, 2021
S. Morri, Il valore distribuibile nel concordato in continuità: APR, RPR e libero arbitrio del debitore, in Ius Crisi d’Impresa, 27 febbraio 2024 S. Morri, Sull’art. 214, comma 1, CCII, e in particolare sul concetto di soddisfazione dei creditori e sulla posizione dell’affittuario dell’azienda prelazionario, in Ius Crisi d’Impresa, 24 gennaio 2024.
G.B. Nardecchia, Il valore di liquidazione, in Il Fall., 11/2024
A. Nigro, Il ruolo e la portata dell’art. 2740 Cod. Civ., in D. Vattermoli (a cura di) La questione distributiva nel diritto della crisi e dell’insolvenza, Pisa, 2023
A. Nigro, La nuova disciplina degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società, in Ristrutturazioni Aziendali, 11 ottobre 2022,
S. Pacchi, Par condicio e relative priority rule. Molto da tempo è mutato nella disciplina della crisi d’impresa, in Ristrutturazioni aziendali, 6 gennaio 2022
I. Pagni, M. Fabiani, Introduzione alla composizione negoziata, in Il Fall., 2021
L. Panzani, Le liquidazioni e le vendite nel Codice della crisi: caratteristiche e ragionevole durata delle procedure, in Il Fall. n. 10/2023
S. Paterson, Judicial discretion in part 26A restructuring plan procedures
C. Paulus, European and Europe’s Efforts for Attractivity as a Restructuring Hub, in Texas International Law Journal, 2021
L. Pecorella, Le classi come tecnica di distribuzione nel concordato in continuità tra dimensione “orizzontale” e “verticale”. Una prospettiva applicativa, in Dirittodellacrisi.it, 17 maggio 2024
M. Perrino, Relative priority rule e diritti dei soci nel concordato preventivo in continuità, in Dirittodellacrisi.it, 12 dicembre 2022
A. Pezzano, M. Ratti, Le regole di distribuzione, in Dirittodellacrisi.it, 6 settembre 2022
V. Pinto, R. Sacchi, Diritti e garanzie comuni dei dissenzienti nel concordato preventivo, negli adr e nel PRO, in Le Nuove Leggi Civili Commentate n. 2/2024
F. Pirisi, La dilazione e la legittimazione al voto dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione nel concordato preventivo, in Il Fall. n. 3/2015
T. Pogoda, C. Thole, The new German Stabilisation and Restructuring Framework for Businesses, in European Insolvency and Restructuring Journal, 2021
R. Ranalli, Con il Codice della crisi il risanamento è con i creditori e non vi è più spazio per chi li pregiudica, in Dirittodellacrisi.it, 18 luglio 2023
R. Ranalli, La soddisfazione parziale dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Il Fall. n. 12/2014
C. Rinaldo, Il salvataggio delle imprese in crisi: l’attuazione della Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza in Germania e in Olanda e prospettive per l’ordinamento italiano, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 6, novembre 2020
T. Richter, A. Thery, Claims, Classes, Voting, Confirmation and the Cross-Class Cram-Down, in INSOL Europe Guidance Note on the Implementation of Preventive Restructuring Frameworks under EU Directive 2019/1023, 2020
F. Rolfi, Ristrutturazione trasversale e principio di non iscriminazione: todos caballeros, in Il Fall. n. 12/2024
M.H. Rosano, A. Turchi, La prevenzione della crisi d’impresa nel sistema francese: la Procedure de Suavaguarde Acceleree (PSA), in Dirittodellacrisi.it, 10 maggio 2024
A. Rossi, I soci nella regolazione della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali, 22 settembre 2022
A. Rossi, Le proposte “indecenti” nel concordato preventivo, in Giur. comm., 2015, I
G. Scognamiglio, F. Viola, I soci nella ristrutturazione dell’impresa, XIII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”, 27-28 maggio 2022
D. Skeel JR, The Empty Idea of “Equality of Creditors”, University of Pennsylvania Carey Law School, 2018
M. Spadaro, Il concordato delle società, in Dirittodellacrisi.it, 13 ottobre 2022
M. Tarabusi, Convenienza, valore di liquidazione, miglior soddisfacimento: se grande è la confusione sotto il cielo, l’alternativa liquidatoria pare eccellente, in IUS Crisi d’impresa, 13 dicembre 2023.
L. Tronci, Il “surplus” concordatario: profili valutativi, in Il Nuovo Diritto delle Società, n. 4/2023, p. 670
D. Vattermoli, Concordato con continuità aziendale, Absolute priority rule e new value exception, in Riv. dir. comm., 2014, II
D. Vattermoli, Ristrutturazione trasversale dei debiti, in D. Vattermoli (a cura di) La questione distributiva nel diritto della crisi e dell’insolvenza, Pisa, 2023
P. Vella, La spinta innovativa dei quadri di ristrutturazione preventiva europei sull’istituto del concordato preventivo in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 18 febbraio 2022
H. Volberda, Crises, Creditors and Cramdowns: An evaluation of the protection of minority creditors under the WHOA in light of Directive (EU) 2019/1023, in Utrecht Law Review, 2021
Cass., 8 giugno 2012, n. 9373
Cass., Sez. 6, 9 settembre 2016, n. 17911
Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2018, n. 1895
Cass, Sez. 1, 14 maggio 2019, n. 12864
Cass., Sez. 1, 17 maggio 2019, n. 13391
Cass., Sez. 1, 8 giugno 2020, n. 10884
Trib. Ivrea, 27 maggio 2022
Trib. Milano, 15 giugno 2023
Trib. Siena, 30 giugno 2023
Trib. Milano, 6 luglio 2023
Trib. Treviso, 10 luglio 2023
Trib. Ferrara, 18 luglio 2023
Trib. Milano, 20 luglio 2023
Trib. Verona, 21 luglio 2023
Trib. Lucca, 25 luglio 2023
Trib. Milano, 28 settembre 2023
Trib. Treviso, 3 ottobre 2023
Trib. Roma, 24 ottobre 2023
Trib. Bergamo, 30 novembre 2023
Trib. Bologna, 5 dicembre 2023
Trib. Roma, 20 dicembre 2023
Trib. Milano, 28 dicembre 2023
Trib. Spoleto, 29 dicembre 2023
Trib. Bologna, 30 dicembre 23
Trib. Lucca 9 gennaio 2024
Trib. Massa, 16 gennaio 2024
Trib. Palermo, 22 gennaio 2024
Trib. Milano, 5 febbraio 2024
Trib. Lecce, 9 febbraio 2024
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2024
Trib. Napoli, 21 febbraio 2024
Trib. Verona, 13 marzo 2024
Trib. Mantova, 14 marzo 2024
Trib. Larino, 19 marzo 2024
Trib. Mantova, 20 marzo 2024
Trib. Avellino, 26 marzo 2024
App. Venezia, 28 marzo 2024
Trib. Monza, 11 aprile 24
Trib. Roma, 11 aprile 2024
Trib. Milano, 11 aprile 2024
Trib. Milano 2 maggio 2024
Trib. Monza, 11 maggio 2024
Trib. Ancona, 15 maggio 2024
App. Ancona, 9 luglio 2024
Trib. Roma, 17 luglio 2024
Trib. Monza, 18 luglio 2024
Trib. Arezzo, 30 luglio 2024
Cass., Sez. 1, 6 agosto 2024, n. 22169
Trib. Udine, 5 settembre 2024
Trib. Torino, 31 ottobre 2024
App. Milano, 8 novembre 2024
App. Brescia, 17 novembre 2024
Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024
Trib. Verona, 12 dicembre 2024
Trib. Firenze, 8 gennaio 2025
Trib. Udine, 16 gennaio 2025
Trib. Milano, 13 febbraio 2025
Trib. Venezia, 13 febbraio 2025
Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 2025
Note: